L’edificio del Makò di Cordenons fu costruito nel 1865, ma dal 1989, dopo la chiusura del cotonificio, quasi tutti i dipendenti furono licenziati e l’edificio abbandonato, lasciando così, implicitamente, carta bianca a chiunque ci volesse entrare. Una sorte simile fecero il cotonificio di Torre e quello di Pordenone.
Ma per noi ragazzi, quel giorno d’estate, questo non aveva nessuna importanza: era ben più di un edificio abbandonato.
Ci guardammo attorno: sapevamo che di lì a poco avremmo fatto qualcosa di sbagliato. Nessuno parlava, se non la vedetta. Via libera. Scavalcammo in fretta il cancello, e iniziammo a muoverci tra l’erba alta.
Sapevamo tutti e tre che essere lì era sbagliato, ma non perché l’ex cotonificio Makò di Cordenons è una proprietà privata ed entrarci significava violare una legge, me perché è un luogo abbandonato e, privato delle persone che ci lavoravano, si era riempito subito di ortiche e di storie, spesso macabre. Queste circolavano nella nostra scuola, ogni giorno diverse, e ognuno ci fantasticava sopra come voleva.
Violare il cancello di quel luogo per noi, a 13 anni, significava rompere la rete di misteri che avvolge qualsiasi luogo abbandonato e, con questo, sfidare le nostre paure e soddisfare la nostra curiosità.
Chi non aveva mai sentito parlare dei terribili “sacrifici umani” che venivano fatti regolarmente lì la notte? Non sapevamo chi fosse stato “sacrificato” ma, ovviamente, il fatto che nella cronaca nessuno riportasse notizia di quegli omicidi, era per noi assolutamente secondario.
Animati da quelle voci, da quei racconti che conoscevamo a memoria, iniziammo ad esplorare gli edifici abbandonati, tra vetri rotti, luci che filtravano tra le sagome delle finestre coperte dalla vegetazione, e tubi di gomma che contenevano una volta il rame. Tra quelle rovine, pareva quasi che i racconti dei nostri compagni prendessero vita.
Finalmente arrivammo al luogo che stavamo veramente cercando: nascosta tra i rovi, una piccola porta in fondo a una stanza aperta, con scritto davanti “la stanza della morte”, annunciava chissà quali terribili mostruosità che dovevano essere avvenute lì dentro.
Nessuno ebbe il coraggio di entrare, così rimanemmo tutti nel dubbio di cosa ci dovesse essere oltre quel serramento di metallo, senza farci mai più ritorno, e continuando a portare la leggenda dentro di noi.
La storia, però, cambia improvvisamente sabato 16 maggio di quest’anno: finalmente, dopo anni di progetti tentanti, ma mai riusciti, nasce una nuova idea. Stiamo parlando de “Il mio Makò”, un progetto gestito da un gruppo di persone, di cui il responsabile è Paolo Lunardelli, che hanno intenzione di ricostruire la memoria storica lasciata dall’ex cotonificio nel nostro territorio.
Ma non si fermano qui. Vogliono anche recuperare il valore architettonico dell’edificio, ritenuto di grande valore.
Mi presento nel pomeriggio di sabato per seguire l’avvio dei lavori di ristrutturazione, che iniziano con la pulizia delle piante attorno agli edifici.
Cartina alla mano, iniziamo a fare un giro degli enormi stabili del Makò.
Mentre facciamo il giro, mi ritorna in mente quel pomeriggio d’estate passato coi miei amici, e con esso anche la “camera della morte”, che tanto ci aveva fatto paura quel giorno, sebbene ne fossimo rimasti fuori.
Allora chiedo di poterci andare e svelare il mistero che da ormai sei anni portavo con me. I responsabili non ne sapevano nulla di quella stanza, e sono io a doverli accompagnare di fronte alla porta.
Tutto è rimasto come lo ricordavo; come una favola, ogni pezzo della storia era rimasto al suo posto, come se avesse aspettato il mio ritorno per continuare a parlare di sé.
E in effetti le voci sulla “stanza della morte” in questi giorni sono continuate a crescere, prima attraverso un post comparso sulla stessa pagina Facebook del progetto, il quale annunciava la scoperta di indicibili resti e scritte trovate nel sito, sottolineando che le autorità competenti sarebbe state presto informate.
Il post ha generato subito l’attenzione della stampa, che ha chiesto dei chiarimenti su ciò che era stato trovato in quel luogo.
Credo che la storia nata attorno al racconto che portavo con me sia stata esagerata e, forse, malintesa.
La mia storia, quella della “stanza della morte”, era solo un ricordo delle medie, frutto di quei racconti che nascono perché nessuno è in grado di dimostrare che non sono veri.
Sono delle storie che nascono attorno al nome stesso del racconto. La stanza esisteva per noi, e per il fatto che c’era una scritta sulla porta a verificare la sua esistenza, non perché questa dovesse esistere veramente.
Ma la realtà è una sola. Sabato 16 maggio siamo entrati, per la prima volta, dentro la famosa stanza, e vi abbiamo trovato una cosa sola: niente.
Un lungo corridoio vuoto, probabilmente destinato al passaggio dell’acqua, privo di aperture sull’esterno, e quindi completamente buio. Niente scritte, nessuna traccia di riti satanici, niente ossa o qualsiasi altra traccia di materiale. Questa è la “stanza della morte”.
Un reportage di Giacomo Netto
Sono nato a Pordenone nel 1994. Attualmente studio Web Marketing e comunicazione digitale presso lo IUSVE di Mestre. Nel fine settimana lavoro in un ristorante tipicamente friulano, esperienza grazie alla quale mi sono avvicinato al mondo dell’enogastronomia locale e ai suoi valori. L’oppure e in particolare la rubrica per cui scrivo, Gusti della terra, rappresentano per me la possibilità di esprimermi: da sempre, infatti, amo scrivere e raccontare delle mie passioni e della mia terra.
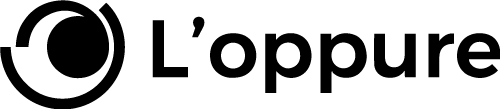

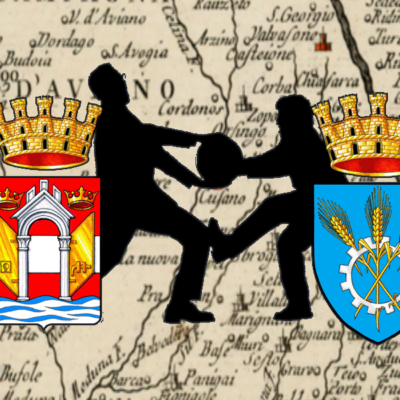

1 Comment