«Der Führer hat schon entscheiden».
Furono queste le parole pronunciate da von Ribbentrop a Ciano che – dopo l’infelice attacco italiano alla Grecia del 1940 – diedero avvio all’occupazione italiana di Ljubljana. L’Asse infatti aveva dichiarato guerra al Regno di Jugoslavia perchè venuto meno al Patto Tripartito a causa di un colpo di Stato, ma soprattutto in vista dell’operazione Barbarossa contro l’Unione Sovietica.
L’ 11 aprile del 1941 le truppe italiane, al comando del generale Vittorio Ambrosio, raggiunsero così l’odierna capitale slovena: l’Italia fascista occupò un territorio di quasi 5000 chilometri quadrati con circa 340.000 abitanti, che chiamò “Provincia di Lubiana”.
Il malumore iniziò a crescere tra la popolazione tanto da trasformarsi in un vero e proprio malcontento politico: il partito comunista sloveno (KPS) fu il primo a captare e a catalizzare il disagio causato dall’aggressione italiana e – raccogliendo attorno a sé fazioni di cristiano-sociali e di liberali – formò, alla fine dello stesso aprile, il “Fronte popolare di Liberazione” (OF). Assenti in tutto ciò, i partiti borghesi.
Dopo l’attacco dell’Asse all’Unione sovietica, l’OF organizzò in tutto il territorio della Provincia di Lubiana, una rete di strutture allo scopo di lottare contro gli aggressori nazifascisti e che mirava soprattutto a recidere tutti i collegamenti ferroviari e stradali di Ljubljana con l’Italia.
Le reazioni dei comandi militari italiani non si fecero attendere: il generale Robotti decimò le forze partigiane e molti furono i rastrellamenti accompagnati anche da violenze verso i civili. Questa dura linea andò ad ingrossare ancora di più le fila della resistenza slovena e Robotti dovette dichiarare “zona di guerra” tutta la Provincia di Lubiana.
Seguirono fucilazioni di ostaggi ed esecuzioni sommarie. Il territorio tra Slovenia e Croazia fu messo a ferro e a fuoco. Bruciarono tantissimi paesi, furono fucilati molti civili e migliaia di uomini, donne e bambini vennero raggruppati e spediti verso i campi di concentramento del confine orientale.
Dopo i processi preventivi fatti dal regime a Trieste nel dicembre del 1941 contro i comunisti e l’unificazione dei due movimenti di liberazione, si assistette a un’escalation dell’internamento per evitare la perdita di controllo della regione a est di Trieste.
Infatti, se inizialmente le strutture dei campi furono concepite solo per neutralizzare gli elementi politici ritenuti pericolosi, successivamente attraverso i rastrellamenti e poi deportazioni, venne colpita soprattutto la popolazione civile, in maggioranza rurale.
Le deportazioni vennero perpetuate senza sosta e nei campi le condizioni di vita furono brutali: «[…] quello che più ricordo è la miseria della natura umana. Le condizioni disumane ci hanno fatto diventare delle bestie in pelle e ossa. Eravamo scheletri ambulanti senza acqua, pieni di zecche e di pidocchi, delle larve piene di piaghe purulente, che puzzavano di sterco proprio e di quello altrui. […] A soffrire era la dignità umana, che scemava di giorno in giorno. […] Forse qui mancavano la camera a gas e il camino, ma a quanto ne so, il livello di disumanità nel quale ci avevano costretto i nostri aguzzini era praticamente uguale a quello nazista.»
A parlare è Herman Janež in un’intervista di Boris Gombač: nato nel 1935 a Stari Kot oggi nella Repubblica Slovena, aveva solo sette anni quando venne internato con la sua famiglia prima nel campo di concentramento di Rab – Arbe e poi in quello di Gonars.
Il campo di Gonars fu realizzato nel 1941 in previsione dell’arrivo dei prigionieri di guerra russi, ma dalla primavera del 1942 venne destinato all’internamento dei civili della Provincia italiana di Lubiana, rastrellati dall’esercito italiano in applicazione della Circolare 3C del generale Roatta, comandante della II Armata.
In questa circolare si specificavano le misure repressive da attuare nei territori occupati, come il titolo di internamento protettivo, precauzionale e repressivo da applicare sia ad individui, famiglie che ad intere popolazioni di villaggi e zone rurali.
Nel campo di concentramento di Gonars, in un primo periodo si potevano trovare intellettuali, studenti, insegnanti, artigiani, operai e artisti. I deportati, quando arrivavano alla stazione ferroviaria di Bagnaria Arsa, venivano insultati dalla popolazione locale fortemente influenza dalla propaganda fascista: li credevano dei banditi e degli assassini. A nulla valevano le repliche dei prigionieri sloveni: «Non siamo banditi, ma studenti buttati giù dai letti solo perché antifascisti! Lottiamo per la libertà.»
Sotto pseudonimo furono internati anche esponenti del’OF, che sarebbero poi diventati dirigenti della Resistenza jugoslava.
Nell’estate del 1942 il campo conteneva già oltre 6000 internati: il doppio della sua capienza. In un secondo periodo, dal campo di Rab – Arbe arrivarono quindi anche gli uomini, le donne, gli anziani e i bambini rastrellati dai paesi del Gorski Kotar, la regione montuosa a nord-est di Rijeka.
Nell’isola di Rab – Arbe, infatti, fu realizzato un immenso campo di concentramento su disposizioni del generale Roatta: esso fu una delle tappe della “bonifica etnica” programmata dal regime fascista.
Il campo di Gonars venne costruito appena fuori dal paese, nella zona oggi limitrofa alla strada statale “Napoleonica”. Era diviso in due settori a circa un chilometro uno dall’altro: il campo A e il campo B. Quest’ultimo era a sua volta suddiviso in tre altri tre: l’Alfa, il Beta e il Gamma. Era circondato da un alto filo spinato, torrette di guardia con mitragliatrici e potenti fari che lo illuminavano a giorno.
Le testimonianze degli ex prigionieri riportano tutte la mancanza soprattutto di acqua, di cibo e di igiene. Condizioni disumane che colpivano soprattutto i bambini, come racconta Marija Poje sempre a Gombač:
«[…] Poi è morto questo mio bambino appena nato. Mi è morto in braccio questo mio Anton, provato dalla fame, dalla sete, dal freddo. E quando è morto questo esserino era solo una sembianza di bambino, solo ossicini, era magro, magrissimo, come un coniglietto. Non chiuse gli occhi per due giorni e poi morì. […] Ed io non ho potuto andare là, non sapevo neanche dove l’avevano sepolto e neanche mi avrebbero lasciato andare al cimitero. Poi arrivò la capitolazione dell’Italia. Ci hanno aperto le porte e siamo andati dove abbiamo potuto.»
Nel settembre 1943, arrivarono gli Alleati e il contingente di guardia fuggì: gli internati furono così liberi di fuggire.
Successivamente la popolazione di Gonars smantellò il campo per utilizzare i materiali in altre costruzioni (ad esempio un asilo), così oggi non rimangono tracce rilevanti del campo. A memoria sorge solo un sacrario all’interno del cimitero del paese friulano, costruito per iniziativa delle autorità jugoslave nel 1973 dallo scultore Miodrag Živković e dove riposano i resti di 453 cittadini sloveni e croati.
Ogni anno vengono celebrate commemorazioni in presenza delle autorità croate e serbe, mentre dal 1975 il comune è gemellato con Vrhnika, cittadina nei pressi di Ljubljana.
Anche la storiografia riguardante il sistema concentrazionario italiano per le provincie del Regno jugoslavo è infatti recente: le pagine buie della Storia dell’imperialismo fascista sono uscite dall’oblio solo grazie al lavoro di Carlo Spartaco Capogreco.
Le ricerche dello storico hanno permesso di ricostruire la complessità del fenomeno di deportazione e oggi sappiamo che non solo nei territori occupati, ma anche in Italia si ricorsero a metodi repressivi che prevedevano l’incendio dei villaggi, la fucilazione di ostaggi civili e la deportazione nei campi di concentramento “per slavi” che furono quindi costretti ad un durissimo e disumano internamento che portò alla morte migliaia di persone tra cui moltissimi bambini.
Capogreco sostiene quindi che l’esercito fascista mise in atto una strategia che spesso mirava ad eliminare le popolazioni locali: «prassi questa che caratterizzò le frequenti “operazioni di polizia” volte al controllo del territorio e si abbinò agli speciali “cicli operativi” antipartigiani, trasformandosi talvolta in vera e propria deportazione di massa, in violazione delle più basilari norme del diritto internazionale. […] In Jugoslavia l’esercito italiano ricorse all’internamento dei civili nel quadro di un’occupazione violenta ed esplicitamente razziale.»
L’internamento quindi, oltre all’obiettivo di allontanare dalle principali località gli individui che potevano aiutare i partigiani o agire in prima persona contro gli occupanti italiani, perseguiva spesso anche il fine della “sbalcanizzazione” del territorio.
Era questo infatti un vecchio proposito fascista e che nella “Provincia di Lubiana” sembrò quasi realizzarsi mediante anche la sostituzione degli autoctoni con coloni italiani provenienti dalle più lontane regioni d’Italia.
“[…] Ogni corpo, ogni individuo ha avuto una propria vita, qualcuno ha nutrito dei sentimenti verso di lui, qualcuno lo aveva amato, e allora non si può far finta di non vedere o di non capire o di essere indifferenti. […] Essere spinti in una fossa comune è la fine di ogni ricordo, di ogni individualità. […] Lo stesso successe anche a noi, ai bambini sopravvissuti ai campi di concentramento di Rab – Arbe e di Gonars. […] Voi non potete capire, ma potete però farlo conoscere perchè questa è una realtà ancora oggi taciuta e poco divulgata” conclude Janež.
Nasce a Palmanova il 12 novembre 1990. Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Udine, è iscritta al corso di Laurea Magistrale Storia Contemporanea a Ca’ Foscari di Venezia.
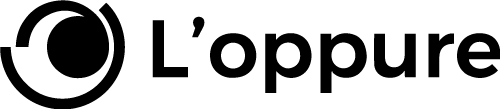





1 Comment