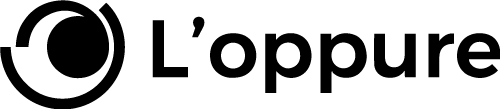Uno scrittore si vede dal secondo romanzo – ecco quello che si dice in editoria. Il primo non conta più di un biglietto da visita in un locale d’incontri: chi ci sta davanti si presenta per come vuole essere visto, resta accucciato nella propria zona di sicurezza speranzoso di non compromettersi. Si ripara le ossa serrando la conversazione entro i limiti del proprio feudo di conoscenze ereditate e piccole nozioni insignificanti. E’ il secondo romanzo che fa lo scrittore. A volte, il quinto.
Marco Missiroli, autore riminese classe ’81, ha pubblicato già cinque romanzi ed è stato il vincitore del Premio Campiello Opera Prima per Senza coda (2005, Fanucci), dei Premi Comisso e Tondelli per Bianco (2009, Guanda), nonché del Campiello Giuria dei Letterati per Il senso dell’elefante (2012, Guanda). La cupa solitudine che spesso vira verso un isolamento forzato, il tenero e sommesso amore familiare, l’ossessione quasi morbosa per la protezione offerta dalle mura domestiche permeano i primi quattro scritti di una sorta di claustrofobia dell’anima, riscattata infine solo dalla condivisione di una segreta verità. Ma è con Atti osceni in luogo privato (di cui avevamo scritto qui), che Missiroli prende il largo dalla costa delle sue sponde natali.
La storia, che narra di una sessualità personale, annunciatrice di ostacoli e salti, fugge dai temi a cui Missiroli avrebbe potuto sembrare confinato: emarginazione sociale, tumulto privato e silenzioso, ricerca di un farmaco per la solitudine. Il giovane Libero Marsell non è un bambino scaraventato nel rapace mondo adulto, nè una neonata storpia o un vedovo incapace di ricostruire le geometrie dell’affetto; è un ragazzo degli ambienti della piccola borghesia parigina, perfettamente integrato. Il suo dramma non parla di infusi letali o di odio xenofobo – il suo dramma parla la lingua del più comune sesso adultero. Di un pompino. Libero è un ragazzo vivace e vitale, protagonista di un romanzo che – più che di formazione – si può definire di realizzazione. Della carne e degli affetti.
Ci tenemmo lì e per la prima volta avvertii la paura che le succedesse qualcosa, e che la mia felicità fosse la sua, e anche i dolori e le apprensioni e le possibilità di qualcosa di buono. Non ero più vulnerabile per me stesso, ero fragile per noi. Passavo dalla prima persona singolare alla prima persona plurale. Intuii lì, in quell’abbraccio furtivo, che avrei potuto prendere le ferite di un altro essere umano e tentare di ripararle, e che io stesso avrei potuto affidarle le mie.