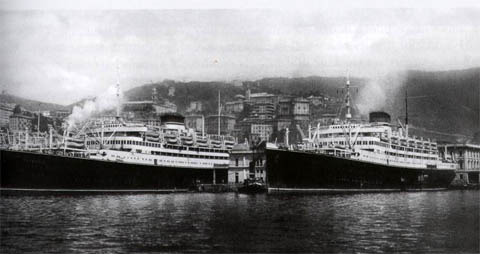Nel cuore dell’autunno del 1918, il Veneto e il Friuli Occidentale si trovavano al centro di un momento storico cruciale. L’Impero austro-ungarico, logorato da anni di guerra e da ammutinamenti sempre più frequenti, si preparava a ritirarsi, e la possibilità di sgomberare il Veneto veniva discussa già il 14 ottobre a Baden. L’ordine era chiaro: l’evacuazione doveva essere graduale, per mettere al sicuro l’immenso materiale bellico accumulato nella pianura veneta. Tuttavia, le truppe imperiali erano esauste, a corto di cibo e munizioni, e il malcontento tra i soldati raggiungeva livelli allarmanti.
A Casarsa, interi reparti, come i croati del I/16 fanteria e il secondo reggimento Gebirgsschutzen, si ammutinarono, segnando il collasso dell’armata occupante. Gli italiani, invece, avanzavano rapidamente oltre il Piave: non erano invasori su un territorio straniero, ma soldati che spesso tornavano a casa.
Tra loro spicca la figura leggendaria del cavaliere bianco Crozzoli, che fece il suo ingresso a Pordenone con i bersaglieri ciclisti tra ovazioni e lanci di stelle filanti sottratte di nascosto dai magazzini della città. Crozzoli troverà la morte poco dopo, a Fiume Veneto, simbolo del sacrificio e del ritorno alla patria.
Ma la liberazione non fu solo epica e simbolica: fu anche violenta e concreta.
A Sacile, per esempio, dodici ore di battaglia tra le case e le strade della città culminarono in uno scontro nella piazza principale, dove bersaglieri italiani e truppe inglesi affrontarono i mitraglieri austro-ungarici appostati nelle celle campanarie. Nei pressi di Tauriano e Istrago, i cavalleggeri del “Saluzzo” compirono cariche disperate contro batterie nemiche, con capitani come Raffaele Libroia che lasciarono la vita sul campo guidando gli uomini alla conquista dei pezzi ancora fumanti.
La guerra, però, per quanto alla fine, mostrava ancora i suoi lati più crudi. Testimonianze dirette, come quella di un soldato inglese, descrivono il ritrovamento dei rottami di colonne di artiglieria nemiche, con lettere e corrispondenza ancora calpestate, corpi di uomini e cavalli ammassati lungo la strada: un paesaggio che, pur non essendo un campo di battaglia attivo, era teatro di orrore e devastazione.
A Pordenone, la liberazione si accompagnò a episodi di eroismo civile. Giuseppe De Carli, detto Ortis, riuscì a proteggere il municipio dalla furia dei soldati in ritirata, salvando documenti e opere d’arte. Don Celestino Sclabi, testimone diretto, racconta il trionfo della città, dall’arrivo del soldato Crozzoli che annunciava la liberazione, alle prime truppe italiane che issavano il tricolore sui campanili, fino al giubilo della popolazione che invase i magazzini lasciati dagli austro-ungarici.
L’avanzata italiana proseguì in tutta fretta verso il Tagliamento, con americani e inglesi che parteciparono all’inseguimento delle retroguardie nemiche, spesso in condizioni estreme, tra ponti minati e artiglierie ancora attive. La vittoria culminò il 4 novembre con l’annuncio dell’armistizio e con la proclamazione del successo della Patria: Trento e Trieste erano finalmente unite all’Italia, e il Friuli Occidentale era liberato.
Dopo la guerra, le testimonianze civili ci raccontano anche il ritorno alla vita quotidiana: la Banca Popolare di Pordenone, salvata dall’avvocato Guido Rosso, poté riprendere le sue attività e assistere i profughi. I sindaci delle città liberate ringraziarono i reparti italiani per il loro comportamento corretto e per aver aiutato la popolazione, contribuendo a ricostruire un tessuto sociale devastato dalla guerra.
Per approfondire:
- Paolo Gaspardo, Pordenone nella Grande guerra. Il Friuli occidentale dall’unità d’Italia al 1918, Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Pordenone, Pordenone, 1991.
- Fortunato Silvestri, Pordenone occupata, 1917-1918. Cronache e memorie di guerra, a cura di Francesco Boni de Nobili, De Bastiani Editore, Vittorio Veneto, 2018.
Pordenonese, classe 1992. Ho conseguito il dottorato di ricerca in Studi storici tra l’Università di Padova, Ca’ Foscari di Venezia e l’Università di Verona. Mi sono laureato a Ca’ Foscari con una tesi sul rapporto tra l’università veneziana e la Dalmazia, premiata dall’Ateneo Veneto nel 2020. Mi piace pensarmi come uno spettatore di eventi che un giorno saranno considerati storia: ciò che viviamo oggi, domani sarà oggetto di studio e di riflessione. Per questo credo che raccontare e divulgare il passato sia una delle sfide più affascinanti. È anche il motivo per cui scrivo con passione per le mie amate Radici.