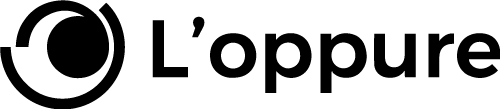C’è qualcosa di incredibilmente paradossale nel fatto che un paese fra i più grandi promotori di libertà, democrazia e necessità dei diritti umani, si attribuisca il diritto di agire in maniera indiscriminata ed incontrollata contro quelli che ritiene criminali. Ma non confondiamoci: il protagonista di questa storia non è un sistema politico complesso o l’interesse di uno Stato, bensì una persona: Omar Khadr, il figlio di Guantanamo.
Omar nasce in Canada nel 1986 e si sente canadese anche se, non ancora adolescente, torna in Afghanistan con la sua famiglia; in seguito ai bombardamenti da parte degli Stati Uniti successivi all’11 settembre, il padre di Omar, un uomo molto discusso, è impegnato a fornire aiuti agli sfollati e ai feriti. Estremamente determinato, pur di continuare la sua missione è disposto a trattare con alcuni componenti di Al Qaeda ed è a causa di ciò che Omar entra in contatto con il gruppo di terroristi. All’inizio sembra che il giovane quindicenne debba solamente tradurre alcune istruzioni, ma l’esercito americano trova delle videocassette che lo mostrano sorridente, intento a costruire esplosivi che sarebbero poi stati usati contro gli Stati Uniti. «Non era una convinzione – dice Omar – ma il riflesso di ciò in cui credevano gli altri intorno a me».
L’esercito americano riesce a capire dove si nasconde il gruppo di terroristi ed il luogo viene attaccato violentemente, tanto che uno dei soldati affermerà: «Ero esterrefatto che dopo tutto il bombardamento ci fosse ancora qualcuno vivo»; dopo questo, paradossalmente, l’attenzione si concentra su Omar il quale, sopravvissuto all’attacco riportando gravi lesioni, viene accusato di essersi difeso, lanciando la granata responsabile della morte di un soldato americano. Da questo momento, la vita del giovane viene bruscamente interrotta: il quindicenne viene interrogato per tre lunghi mesi a Bagram, attraverso metodi terribili e subendo violenze fisiche e psicologiche al limite. Successivamente – e poiché “si rifiuta di collaborare” – viene trasferito nel neonato campo di prigionia di massima sicurezza a Guantanamo Bay, dove continua ad essere sottoposto a torture di ogni tipo, umiliato ed umanamente distrutto.
L’avvocato canadese Dennis Edney, che ha dovuto aspettare ben quattro anni prima di poter difendere Omar e lo sostiene nella causa contro il Governo statunitense, consiglia al giovane di dichiararsi colpevole per avere la possibilità di patteggiare e non trascorrere il resto della sua vita a Guantanamo. Così, dopo 10 anni di difficili rapporti legali caratterizzati dall’avversione del Primo Ministro canadese Harper per il suo ritorno nel paese, Omar viene portato in Canada dove vive, in libertà vigilata, proprio con la famiglia del suo avvocato. La caratteristica che più meraviglia nel vedere il giovane oggi è il suo sorriso, che sopravvive assieme alla sua gentilezza nonostante gli anni di carcere che l’hanno privato di una fase della vita insostituibile.
Il film-documentario che racconta la travagliata storia di Omar si intitola Guantanamo’s Child ed è stato proiettato – per la prima volta in Italia – durante Le Voci dell’Inchiesta 2016, alla presenza del regista Patrick Reed. A svolgere gran parte del lavoro di documentazione sulla vicenda del giovane e sulle condizioni a Guantanamo è stata, tuttavia, la giornalista Michelle Shephard, che ha poi diretto il film assieme a Reed.
Un capolavoro dell’inchiesta, che a Pordenone ha ricevuto il Premio del Pubblico come miglior film del festival e che mostra le contraddizioni di un paese come gli Stati Uniti, che si erge a difensore mondiale dei diritti umani e della pace mentre continua a permettere – se non addirittura a promuovere – la violenza incondizionata contro i suoi nemici, nascondendosi dietro l’assurdità di «è la legge della guerra: automaticamente, i feriti divengono responsabilità tua e li devi salvare».

Sono nata il 7 settembre 1997 in provincia di Pordenone e frequento il primo anno di Infermieristica presso l’Università di Trieste. Fastidiosamente pignola e con la testa perennemente fra le nuvole, amo avere sempre un sacco di cose da fare. L’oppure rappresenta per me la possibilità di coltivare attivamente la passione per il giornalismo, condividendo la bellezza dei territori che amo.