“Le restrizioni sono spesso fonte d’ispirazione per un autore poiché gli permettono di superare se stesso. […] Invece di lasciarsi distruggere la mente e lo spirito e di lasciarsi andare, invece di lasciarsi pervadere dalla collera e dalla frustrazione, Jafar Panahi ha scritto una lettera d’amore al cinema. Il suo film è colmo d’amore per la sua arte, la sua comunità, il suo paese e il suo pubblico.”
Con queste parole Darren Aronofsky, presidente della giuria del Festival di Berlino 2015, premia con l’Orso d’Oro Taxi Teheran di Jafar Panahi, uno dei più acclamati tra i registi iraniani contemporanei. Panahi, tuttavia, non è presente per ritirare il premio. Il 2 marzo 2010 infatti, in seguito ad una manifestazione di protesta contro il regime iraniano, viene arrestato con l’accusa di “propaganda anti islamica”; grazie alla mobilitazione del mondo del cinema verrà rimesso in libertà su cauzione il 24 maggio dello stesso anno, con il divieto di lasciare il paese e di girare film per i prossimi vent’anni. Nel 2011 esce This Is Not a Film, nel 2013 Closed Curtain, nel 2015, appunto, Taxi Teheran.
Alla stregua di Dieci di Abbas Kiarostami (2002), Taxi Teheran è interamente ambientato nell’abitacolo di uno dei tanti yellow cabs che pullulano in città: un continuo campo-controcampo ci mostra le strade, la vita pulsante della metropoli iraniana e, dall’altra parte, i passeggeri del taxi di cui lo stesso regista, che non si prende la briga di mascherarsi dietro un nome fittizio, è il conducente.
Il cinema mediorientale, a parte Kiarostami, aveva conosciuto un altro precedente, in termini di tecniche di ripresa: il film sulla prima guerra del Libano Lebanon, del regista israeliano Samuel Maoz, interamente girato dall’interno di un carro armato. È anche vero però che lo spazio angusto, prigione e salvezza dei soldati, l’adrenalina e il crudo espressionismo della guerra della pellicola di Maoz, non potrebbero essere più distanti dal tranquillo scorrere di una giornata qualsiasi di Taxi Teheran. Una maestra elementare progressista che discute con un borseggiatore, due anziane infatuate dei loro due pesci rossi, la nipotina del regista Hana Saeidi e l’avvocatessa attivista Nasrin Sotoudeh, persone reali, con nomi reali: ognuno dei passeggeri del taxi rappresenta un punto di vista sulla società iraniana, che nel corso del film si delinea davanti agli occhi dello spettatore nei suoi tratti più quotidiani e contraddittori.
Non è il virtuosismo di un artista nella condizione di impiegare liberamente tutti i trucchi del mestiere, non è tantomeno la trama a rendere questo film tanto eloquente quanto le esplosioni e il respiro mozzato di Lebanon. La sua forza emerge dai dettagli; la piccola Hana, che recita allo zio il decalogo, imparato a scuola, per un “film distribuibile” (niente vestiti occidentali, niente “sordido realismo”, i personaggi possono avere solo i nomi dei santi dell’Islam, nessun contatto tra uomo e donna), o che candidamente si chiede perché il realismo del regime si applichi solo alla minima parte della realtà dei fatti. La sua innocenza infantile rende evidente tutta la crudezza del sistema di pensiero degli Āyatollāh, “clero” nonché ceto dominante dell’Islam sciita e, più in generale, della rigida applicazione della Shari’a, la legge di Dio, nonché scienza giurisprudenziale islamica.
Con il “sordido realismo” di Taxi Teheran, Panahi non solo dimostra che il cinema può essere un’arma di protesta incredibilmente efficace ma, con la più grande semplicità, ci fa capire che il quotidiano può smuovere le coscienze al pari dell’inaudito, e molto più da vicino. Il paese dove l’omosessualità e l’adulterio vengono puniti con la pena di morte, è nondimeno un paese di artisti, poeti, intellettuali di ogni sorta, che si fanno immagine di un cambiamento possibile anche grazie al veicolo delle arti.

Sono nato a Pordenone nel 1993. Mi divido tra musica e lettere; gli studi classici, la scrittura e le lingue straniere, si accompagnano a pianoforte, chitarra, voce e teatro. Mi interesso di geopolitica e diritti umani e già mi sono imbarcato in varie esperienze di volontariato, soprattutto in Palestina.
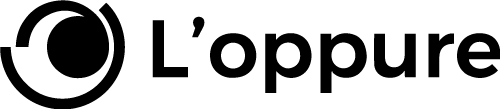

1 Comment