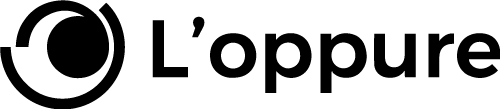L’ultima fatica di Matteo Garrone è, a mio avviso, uno dei più bei film italiani del 2018 e conferma il regista romano come una delle due più interessanti personalità (assieme a Sorrentino) della contemporanea cinematografia nazionale, capace di creare opere avvincenti, innovative e profonde e soprattutto di approcciarsi ai generi tradizionali in modo personale reinterpretandoli, mescolandoli e sovvertendoli dall’interno, ottenendo prodotti spiazzanti e assolutamente unici.
In questo caso i generi messi in campo sono addirittura tre, apparentemente inconciliabili.
In superficie “Dogman” sembra un classico gangster movie, crudo e realistico, sulla scia di Gomorra: ci sono i soliti brutti ceffi, i soliti degradati scenari di una periferia meridionale magistralmente fissati su pellicola dalla grigia fotografia del danese Nicolai Brüel, le solite imprevedibili esplosioni di violenza selvaggia e incontrollata.
Ma c’è anche il western: il classico canovaccio del villaggio tiranneggiato dal prepotente di turno che viene alla fine sconfitto dall’eroe solitario; l’ombra lunga di Sergio Leone si staglia su tutta la pellicola.
E soprattutto c’è, come nel precedente “Il racconto dei racconti”, la fiaba: l’ambiguo rapporto di amicizia/schiavitù/rivalità tra il debole e sottomesso “canaro” Marcello e l’erculeo ex pugile Simoncino è chiaramente quello tra Pollicino e l’orco. È l’antichissimo e immortale archetipo mitologico del piccolo che trionfa sul grande, dell’astuzia che ha la meglio sulla forza bruta – Davide e Golia, Ulisse e Polifemo – e lo stratagemma finale della gabbia ricorda il forno in cui viene rinchiusa la strega di Hansel e Gretel.
Persino il luogo in cui si svolge la vicenda, all’apparenza così realistico e concreto, è in realtà fittizio e indeterminato: il set è quello di Castel Volturno in provincia di Caserta, la Campania di “Gomorra”, ma i dialoghi sono in uno straniante romanesco. È il classico “paese lontano lontano” di tutte le fiabe, un non luogo che sta per tutti i luoghi di tutti i tempi; da questo punto di vista anche il fatto di cronaca nera a cui Garrone si è liberamente ispirato (il delitto del Canaro della Magliana del 1988) perde d’importanza, si tratta di una storia universale che potrebbe avvenire dovunque e in qualunque epoca, come le fiabe, appunto.
Ma questa è una fiaba moderna, una fiaba nera, realistica e disincantata, in cui non ci sono buoni e cattivi o una divisione netta tra bene e male. Entrambi i protagonisti sono, ciascuno a suo modo, negativi e sgradevoli ed entrambi sono in fondo delle vittime; l’ “uomo cane” del titolo potrebbe essere tanto il brutale Simoncino (che si esprime quasi solo a mugolii, come un cane viene ammansito solo dai bocconcini di droga e alla fine viene messo alla catena come il pitbull della profetica scena iniziale) quanto il servile e sottomesso Marcello che solo alla fine troverà il coraggio di ribellarsi al suo aguzzino. Fondamentale in questo senso l’apporto dei due bravissimi interpreti principali Edoardo Pesce e Marcello Fonte, ma sono da citare tra gli altri anche l’orafo di Adamo Dionisi e il barista di Francesco Acquaroli.
In questo mondo marcio e corrotto nessuno è realmente innocente, tranne i bambini, l’inconsapevole figlia di Marcello interpretata dalla piccola Alida Baldari Calabria, e gli animali, i cani che da dietro le sbarre delle loro gabbie assistono spaventati e impotenti allo scatenarsi della bestialità umana.
E quando alla fine l’improbabile eroe arriva sulla piazza del paese con le spoglie del nemico sconfitto in spalla – come un moderno Cristo che porta la sua croce, altro archetipo mitico – si ritrova solo, non c’è nessuno a festeggiarlo per la sua impresa. Nel mondo reale non esiste vittoria o lieto fine.
Laureato in Letteratura e Filologia aspiro a diventare un insegnante. Le mie grandi passioni: la lettura e la recitazione; dall’unione di questi interessi è nato Jukebox Letterario, un programma radiofonico, con cui cerco di avvicinare un numero maggiore di persone, specialmente giovani, al magico mondo dei libri e della cultura, mostrandone i lati più buffi e paradossali. Spero, con i miei articoli per L’oppure, di dare un altro piccolo contributo in questo senso.