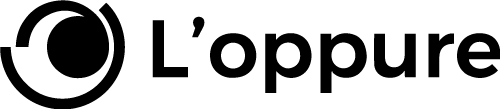Uno legge “Novecento”, con sottotitolo “un monologo” e si aspetta un excursus barboso sul secolo breve, da evitare come degli stivali puzzolenti. Uno si chiede com’è possibile che ne abbia tanto sentito parlare.
E un giorno, per caso, scoprendo per vie traverse che in realtà il racconto tratta di musica, l’uno di cui sopra decide di provare. Così, come si prova una ricetta nuova con un ingrediente di cui si diffida ma che ha un profumo irresistibile. D’improvviso qualcosa che non ha mai attratto la tua attenzione diventa una gemma luccicante in un mare opaco, qualcosa che bisogna leggere. Ora, adesso. L’uno si mette a leggere… E capisce.
Ah, ecco perché ne aveva tanto sentito parlare. Già. Proprio così: perché è magnifico. Niente meno che un’armonia leggera che sincronizza il cuore al battito delle stelle, sul fresco orizzonte dell’oceano. Come può essere?
Aspettò che finissi, senza dire una parola. Poi mi chiese.
«Cos’era?»
«Non lo so.»
Gli si illuminarono gli occhi.
«Quando non sai cos’è, allora è jazz.»
Gennaio 1927. Un giovane trombettista si mette in coda per salire a bordo di una nave, il piroscafo Virginian, quello che salpa per la fantomatica America. L’America che già si cela negli occhi da bambino di chi la vedrà, come se avesse quell’istante già stampato nell’iride. Il trombettista sa che su quella nave si suona il ragtime, “la musica su cui Dio balla, quando nessuno lo vede”. Non solo, corre voce infatti che su quella nave ci sia un pianista molto particolare, con un lungo nome strano, un nome “con un gran finale”, capace di una musica ancora più strana, ipnotica, da cui non si può scappare e dalla quale non ci si può nascondere, dalla quale non ci si vuole nascondere affatto. Egli non vanta nobili origini: non più nobili di una scatola di cartone lasciata in prima classe, in ogni caso. Sul pianoforte.
Baricco ci racconta d’un fiato la storia di questo pianista, attraverso le parole di colui che diventerà suo amico e con cui condividerà le molte traversate. Il trombettista Tim infatti si imbarca: “primo viaggio, prima burrasca, Sfiga.” L’unica cosa che egli può fare durante la tempesta, tra le scarse alternative, è smettere di suonare la tromba. Si mette così a vagare per la nave in piena notte, sperando di non fare la fine del topo, sbattendo da tutte le parti, finché una sagoma nera ed elegante si para davanti a lui. La sagoma gli sorride, e lo invita a seguirlo.
Ci sono, a volte, degli avvenimenti che sigillano le amicizie con ceralacca e timbro: quella notte il pianista e il suo pianoforte ballano, assieme a Tim, la danza impossibile dell’oceano, su note che scivolano via dai tasti come ghiaccio sulla bottiglia di champagne. La nottata finirà con entrambi che ridono a crepapelle dopo i rimproveri disumani del comandante che li ha colti in flagrante.
«Toglimi i fermi», disse. La nave ballava che era un piacere, facevi fatica a stare in piedi, era una cosa senza senso sbloccare quelle rotelle.
«Se ti fidi di me, toglili».
Questo è matto, pensai. E li tolsi.
Non vi dirò come si chiama il pianista. Non vi dirò chi vincerà la sfida, quando Jelly Roll Morton, autoproclamatosi inventore del jazz, salirà a bordo del Virginian, spronato dalla chiacchiere che sostengono non essere lui il più grande, davanti a un pianoforte. Non vi dirò che fine farà il piroscafo, se riuscirà a sopravvivere alla guerra o meno. Non vi dirò nemmeno se il pianista scenderà mai dalla nave. Vi dico: leggete Novecento, di Alessandro Baricco, un monologo. Tornatore ci ha tratto un film, ma voi leggete il libro (se siete ancora in tempo, o anche se siete in ritardo), fidatevi. Potreste capire, tra una nota nuova e un’onda che s’infrange a prua, come si fa ad accendere una sigaretta con un pianoforte.
Vivo in Carnia, a qualche minuto in bici da Tolmezzo, dal 30 luglio 1993. Dopo anni di inedia spirituale in un girone del liceo scientifico, prendo una boccata d’aria in Università a Udine, laureandomi in Turismo Culturale. Amo il sole sulle valli della mia terra, ma amo ancor di più le parole in nero su bianco. Scrivo per la rubrica Pensieri, raccontando agli altri le voci e le storie che incrocio e che mi lasciano qualcosa dentro.