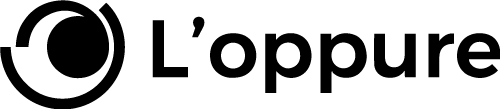Sediamo in cerchio, tra volontari, palestinesi ed internazionali. Sediamo intorno a Khaleed, una cinquantina d’anni, sguardo fermo e barba incanutita, mentre ci parla della sua terra, il villaggio di al-Walaja, sud ovest di Gerusalemme, occupato da Israele il 21 ottobre 1948: ad oggi 17mila anime, circondate dall’insediamento israeliano di Har Gilo e da altri insediamenti più piccoli, in continua espansione. Da anni Khaleed riceve offerte irripetibili da parte dello stato israeliano in cambio della sua casa, ma lui, testardo, non accetta. Non se ne vuole andare, anche se gli insediamenti fagocitano terreno ogni giorno di più: anche se dietro di me, a cinquanta metri da questa casa, c’è il muro. Ieri l’ho visto da vicino. Ho poggiato il naso sul cemento, per sentirne l’odore, e ho guardato in alto, per vedere quanta parte di cielo mi nasconde, con i suoi dieci e più metri d’altezza. Il muro che ormai da anni assiste impassibile ai tormenti di questa terra, come se non c’entrasse niente, come se fosse sempre stato dov’è. Si staglia immobile tra uno studente e la sua scuola, tra un contadino e la sua terra. Tra Khaleed e i suoi ulivi, che ama più dei figli.
Non ho mai imparato a disegnare. Lo dico, perché vorrei saperlo fare ora, per descrivere ciò che mi trovo davanti. Maha, ventidue anni, vive ad al-Walaja e studia traduzione all’università di Betlemme; tedesco, inglese, arabo. Vuole girare il mondo, ma poi vuole tornare in Palestina, ad insegnare lingue in una scuola. Maha è vestita all’occidentale, indossa un paio di nike sportive, jeans chiari e un cardigan lungo a righe bianche e nere. In testa porta un velo azzurro scuro, un colore stupefacente, fermato da due spille ai lati. Siede in cerchio con noi, le braccia incrociate, lo sguardo basso. Il corpo esile e flessuoso è coperto nonostante i quaranta gradi, il velo azzurro la protegge dai nostri sguardi. Ha le borse sotto gli occhi, i lineamenti affilati del naso lungo cui due linee oblique, dall’interno degli occhi, solcano le guance verso l’esterno.
Il mio sguardo indugia su Maha più del dovuto, più di quanto preveda il costume. Qualcosa in lei mi trasmette una profonda inquietudine: è molto magra; cerco di renderla rachitica ai miei occhi, sgradevole, più vicina a me, ma lei si ribella, conserva la sua natura irreale. Mi trovo ad idealizzarla, a trovarla disumana. Non è così che un essere umano si presenta al mondo. Ciò che mi sta davanti è il risultato di un ambiente malato, di uno stato di conflitto permanente, che lascia i suoi segni su ogni cosa. Maha sorride di rado: vive il contatto con diffidenza. È abituata a doversi difendere, dai soldati, dai coloni degli insediamenti che passeggiano in famiglia con il fucile sottobraccio, da chi le impedisce un’educazione, una vita normale.
Al-Walaja è a 8.5 km da Gerusalemme, città sacra di tre religioni, ma molti dei suoi abitanti non ci possono andare. Ai cittadini arabi della Cisgiordania è vietato andare a Gerusalemme, se non in casi straordinari. Alcuni non ci sono addirittura mai stati; si parla di Gerusalemme come di una città del mito, una fortezza inespugnabile, un Olimpo ricoperto di nuvole, ma i cui grattacieli si vedono dalla finestra. Non si capisce finché non ci si è dentro, vorrei dire. Ma non è vero. Non si capisce finché non si dispone soltanto di un passaporto e di una cittadinanza palestinese. Gaza, Gerusalemme Est, o la Cisgiordania, diverse situazioni, stessa vita in prigione. Visitare una prigione non rende prigionieri, non rende partecipi, ma relega nel limbo degli osservatori, ciò che sono io, ora, seduto a questo cerchio: io, che non ho mai vissuto tra i muri che non proteggono, tra le macerie di case demolite, che vivo nell’illusione della vita.

Sono nato a Pordenone nel 1993. Mi divido tra musica e lettere; gli studi classici, la scrittura e le lingue straniere, si accompagnano a pianoforte, chitarra, voce e teatro. Mi interesso di geopolitica e diritti umani e già mi sono imbarcato in varie esperienze di volontariato, soprattutto in Palestina.