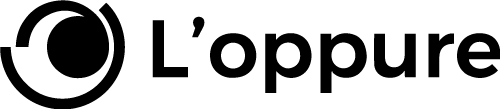E’ legittima la speranza di poter distillare il carattere universale di un’infanzia, circoscritta quanto una guerra di un secolo ormai passato, dalla sterilità degli episodi interamente personali e privati? Ogni vita, in quanto ancestrale ricerca di identità, esige comprensione: racconto, dunque. Per dirla con Garcia Marquez:
La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla.
Una bambina senza stella, romanzo autobiografico della psicanalista Silvia Vegetti Finzi, risponde con forza a quel primo dubbio. Nonostante la specificità del racconto, riesce facile sottolineare le paure, le fantasie, le necessità condivise – essenza di ogni fanciullezza. La narrazione procede seguendo la linea temporale dei primi cinque anni di vita della protagonista, ed è affidata all’alternarsi di due sguardi complementari, anche se paralleli: quello dell’infanzia e quello storico-psicologico dei ricordi profondamente lucidi della maturità, che tuttavia riesce a svincolarsi da facili digressioni tecniche nel campo della psicanalisi, e in generale a mantenere ed esaltare l’impronta familiare e intima del racconto.
In un’Italia fascista, il primo ricordo – probabilmente comunione tra racconti altrui e fantasie personali – della protagonista rimanda ad una perdita: il padre, ebreo, è costretto alla fuga in Africa dalle recenti leggi razziali e all’abbandono della figlia, ancora in fasce. Questa, dopo un periodo di transizione, vorrà come nuova casa quella di un’anziana coppia, lontana parente del padre: i bambini – spiega l’autrice – posseggono la peculiare abilità di saper scegliere i propri referenti; e non solo: il loro interesse si rivolge a quegli adulti che sanno conservare un grano di fanciullezza, perchè con essi possono condividere paure e speranze. Lasciata a se stessa, la piccola sarà immersa nell’enorme mare delle cose che la circondano; quello che percepisce è un mondo necessario, l’unico ammesso tra le infinite possibilità. Ma esiste una reale alternativa, da ricercarsi nella fantasia, nel respiro dei grandi transfert della fanciullezza, nei grandi salti sull’Altro, nella sacralità della domanda: qual è il primo libro che ricordi di aver letto? E’ quello, in effetti, che con maggior forza plasma la nostra vita – e ne suggerisce il destino. La dissonanza di questa vita solitaria con i due vecchi zii viene interrotta dall’inatteso ritorno della madre, sconosciuta: la separazione riuscirà traumatica, per chi percepisce l’immutabile atemporalità della propria infanzia. Sembrava che il mondo dovesse durare per sempre, e invece era per sempre mutato. Il superamento dello strappo viene affidato alla secolare eredità di femminile resistenza ad un mondo plasmato da e per gli uomini, ad un’innata capacità delle donne di sviluppare una certa finezza del vivere, una capacità di esistere in sé e per sé. Trova uno spazio interiore profondo in grado di contenere quel dolore, respinto con un certo fastidio dal mondo esterno. I bambini precipitati richiedono però la necessità di trovare nell’altro uno specchio, una conferma della propria individualità; si espongono come attori, cercano di placare il bisogno di sentirsi qualcuno. Questi bambini non hanno bisogno raccomandazioni ad accogliere ogni gentilezza con un ringraziamento: lo fanno da sé. La figura inaffettiva di una non-madre crea dunque un vuoto, un gap sentimentale riempito dalle lusinghe di un’insegnante: sarà la prima a lodare l’individualità della piccola, inaugurando una stagione di riottosa guerra di liberazione privata, aprendo la voragine del bisogno vitale di autoaffermazione.
I bambini possono farcela da soli: tutto quello di cui necessitano è vuoto, autonomia – rischio. Il rischio, in particolare, forza la crescita; tuttavia quella attuale sarà la prima generazione ad ignorare le ginocchia sbucciate, e i suoi rappresentanti non potranno compensare la fragilità con la spavalderia.