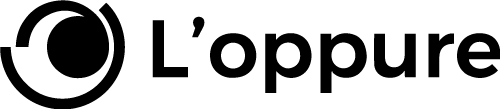Un consiglio antropologico: chiunque volesse affettare il consorzio umano in categorie generazionali, potrebbe trovare d’indicibile utilità l’individuazione di oggetti quotidiani rappresentativi di ognuna. Se volessi tracciare una sorta di equazione, la trasmissione televisiva I fatti vostri, in-onda-tutti-i-giorni-della-settiamana-dalle-undici-alle-tredici, starebbe allo stereotipo della vedova ultrasettantenne come Paura e delirio a Las Vegas (/Blow/Trainspotting) sta ad uno qualunque dei milioni di adolescenti che hanno sviluppato un privato e tumultuoso senso di dovere alla ribellione. Il lungometraggio, confezionato nel 1998 da Terry Gilliam e interpretato da Johnny Depp e Benicio del Toro, descrive i viaggi on the road di un dottore in giornalismo, Raul Duke, e del suo presunto avvocato samoano, il dottor Gonzo, in una Las Vegas bifronte durante uno qualunque dei primissimi anni Settanta: difficile capire se la città avesse intuito già da tempo il vuoto che si nasconde dietro le due parole più ciarlatane del Novecento – ovvero American Dream, o se vivesse in una paranoica condizione di rifiuto, come un orfanello che nutre nella propria testa l’illusione di un padre astronauta cacciatore di draghi galattici.
Il film è l’adattamento cinematografico del quasi omonimo romanzo semi-autobiografico Paura e disgusto a Las Vegas del giornalista Hunter Thompson, noto per essere stato il capostipite del gonzo journalism e per aver intervistato George McGovern, candidato democratico alle elezioni presidenziali del 1972, davanti ad un orinatoio. Nella nota biografica comparsa all’interno della prima edizione britannica di Fear and Loathing in Las Vegas, di lui si può leggere:
Hunter S. Thompson è uno scrittore freelance e un politicante fallito di Woody Creek, Colorado, che ha cominciato a scrivere quando ha avuto bisogno di soldi per rianimare un poco il suo regime di vita. Fino a oggi i suoi lavori pubblicati sono stati pochi e radi – ma attualmente si sta rovinando la salute nell’improbabile ruolo di “corrispondente da Washington” per Rolling Stone. Alla metà degli anni Settanta – dopo due anni trascorsi a Rio come corrispondente per il Sudamerica del National Observer – Thompson si è ritrovato profondamente coinvolto con la sottocultura della droga e della violenza nell’area di San Francisco. E’ stato in questo periodo che ha scritto il suo malfamato classico Hell’s Angels: A Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs. Subito dopo, sofferente di shock culturali e salvaggi flashback, si è ritirato a Woody Creek ad allevare Wild Boar e Dobermann Pinschers. Ma la sua vita si è pericolosamente alterata quando si è fatto coinvolgere in un locale movimento politico noto con il nome di “The Aspen Freak Power Uprising”, cosa che ha causato sollevazioni talmente drastiche nella comunità da costringerlo a partecipare a una frenetica consultazione elettorale per la carica di sceriffo che ha attirato l’attenzione di tutta l’America e devastato l’integrità,ad Aspen, di entrambi i maggiori partiti. Come candidato del Freak Power Uprising è stato sconfitto di stretta misura. Nel frattempo l’autore continua a lavorare lungo le sue strane tangenti, apparentemente insensibile al pubblico disprezzo, alle acclamazioni e a critiche di qualsiasi sorta. Egli è conosciuto, tra i suoi pochi amici, come un eremita coatto con un debole congenito per le 44 Magnum e la musica estremamente amplificata. In termini di retroterra neopertinente, Thompson è nativo di Louisville, Kentucky. E’ stato cronista sportivo in Florida, e sulla base di quell’esperienza gli è stata assegnata da Time Inc. una borsa di studio in giornalismo, o qualcosa di simile, presso la Columbia University di New York, che però non ha dato frutti. Suoi scritti sono comparsi su numerose testate: Esquire, The Nation, The New York Time Magazine, The Reporter, Scanlan’s Magazine, Rolling Stone e Spider.
Nonostante sia avvolta nel mistero, si può ritenere che gran parte della precedente biografia riporti una versione dei fatti soddisfacentemente vicina alla realtà. Reale è la sua candidatura a sceriffo di Aspen da indipendente: il simbolo della campagna fu una mano con due pollici che stringe un peyote, pianta grassa usata principalmente per l’estrazione della mescalina. Reali sono le pubblicazioni e l’amore per le armi di grosso calibro. Paura e disgusto a Las Vegas fu edito per la prima volta da Rolling Stone nel 1971, diviso in due puntate: fu veramente il libro cult di quella generazione di spostati, fricchettoni, e – con buona approssimazione – delusi. In Italia venne pubblicato con scarso successo nel 1978, e in seguito nel 1996 con una nuova e fortunata traduzione di Sandro Veronesi, recante un’interessante “Piccola Enciclopedia Psichedelica” in appendice.
Inviati a Las Vegas con il compito di redigere un articolo su una corsa motociclistica – la favolosa Mint 400, i due protagonisti si prefiggono l’obiettivo di stanare, nella città delle voluttà, l’ultima coda del grande Sogno Americano. Un viaggio che dalle primissime battute scopre i genitali: la matrice è grottesca, comica, disperata e certamente parecchio sconvolgente. In preda al più vasto campionario di scintille mentali, scatenato dalla raccolta meticolosa di una serie allucinante di droghe e dall’idiosincrasia di una città che ha dimenticato i nessi logici, i due prendono a testate i pugni chiusi di una realtà avversa, colpevole, arresa all’inerzia. Il romanzo può vantare uno stile unico: i ritmi serrati, i dialoghi caustici, l’apparente casualità delle scelte narrative raggiungono una sorta di potenza ansiosa. Da Duke – pseudonimo dell’autore – e Gonzo, costantemente schiaffeggiati da una nuova e selvaggia combinazione di stupefacenti, il Lettore è attratto per sadismo: il mezzo narrativo usato per mantenere la suspense, ovvero l’idiozia dei fumi psichedelici, agisce da costante minaccia di abisso sotto le suole dei due, e risulta di indiscutibile efficacia. La successione interminabile di disavventure, minacce armate, truffe aggravate, effrazioni e sfide al limite della fortuna che un essere umano può legittimamente aspettarsi mantiene un ritmo martellante per l’intera durata del racconto, senza mai riuscire piatta o monotona; il merito è certamente del costante – a volte impercettibile, altre lampeggiante – cambio di colore: ogni scena scaraventa il protagonista nel baratro delle emozioni umane coniugate al superlativo assoluto. Rabbia, terrore, euforia, disorientamento raggiungono il grado supremo. La vera forza del romanzo, tuttavia, si nasconde con timidezza quasi verginale; i trip acidi, le sbornie da etere, le allucinazioni della mescalina scansano con ironia verso lucidissimi monologhi incentrati sulla fine di quel Sogno Americano inteso come infinito spettro di possibilità riservate all’individuo e alla comunità intera, infranto dal borioso realismo della maggioranza silenziosa nixoniana, dalle leggi millenarie del quotidiano e del lungo termine. Ritiratisi gli anni Sessanta e le promesse di pace e giustizia sociale che erano giunte spinte dal vento, da Bob Dylan, dalle proteste contro la guerra in Vietnam, dagli slogan di John Lennon, dalle marce di Martin Luther King Jr. e dalle promesse di saggezza psichedelica di Tim Leary e dei Doors, Thompson ebbe il merito di spremere il rantolo finale dalle corde vocali di quelli che fino a pochi anni prima erano stati giovani in quel certo senso che è possibile non perdere mai. Fu il solo, tra i protagonisti di una disfatta che anche oggi prende per la gola e toglie ossigeno, a intravedere il valore di quegli anni dimenticati, accartocciati nell’angolo dei francobolli utili solo a spedire la posta: vale a dire la capacità, effimera come tutte e sole le cose che vale davvero la pena di avere, di quel grande sogno di essere convincente e aver permesso a qualcuno, in un qualche fragile angolo di tempo e mondo, di credere – credere davvero – in qualcosa.
E quella, credo, era la nostra ragion d’essere – quel senso di inevitabile vittoria contro le forze del Vecchio e del Male. Vittoria non in senso violento o militare: non ne avevamo bisogno. La nostra energia avrebbe semplicemente prevalso. Non c’era lotta – tra la nostra parte e la loro. Avevamo tutto l’abbrivo noi; stavamo cavalcando un’onda altissima e meravigliosa…
Ora, meno di cinque anni dopo, potevi andare su una qualsiasi collina a Las Vegas e guardare verso ovest, e con gli occhi adatti potevi quasi vedere il segno dell’alta marea – quel punto in l’onda, alla fine, si è spezzata per tornare indietro.