Il Tagliamento è un fiume capriccioso e maestoso, il più libero rimasto delle Alpi. Dall’alto delle Dolomiti di Forni di Sopra scende come un torrente impetuoso, ma nella Bassa Friulana si apre in una distesa d’acqua e ghiaia larga chilometri. È un fiume che respira: cambia forma, divaga, si sposta. E proprio per questo, da secoli, è anche un fiume temuto.
Già nel Medioevo le cronache ricordano piene che sconvolsero la pianura. Non esistono dati idrometrici, naturalmente, ma le fonti raccontano di corsi d’acqua che cambiavano direzione, di ponti spazzati via e di popolazioni costrette a rifugiarsi sulle alture moreniche. Solo con l’Ottocento arrivarono le prime opere di contenimento. Ma gli argini, appena costruiti, furono messi a dura prova. L’alluvione del 28 ottobre 1882 resta uno degli episodi più drammatici dell’epoca: piogge torrenziali e ondate di piena ruppero gli argini tra Madrisio e Ronchis, sommergendo intere campagne.
Ciononostante fu nel novembre del 1966 che il Friuli si trovò al centro di uno degli eventi naturali più devastanti della sua storia recente. Gli stessi giorni sono noti per gli analoghi disastri che interessarono Firenze, con lo straripamento dell’Arno, e Venezia, con l’acqua alta più grande di sempre. Le piogge, incessanti e battute da un vento di Scirocco caldo e umido, caddero per giorni senza tregua. Ne pordenonese, le strade si trasformarono in torrenti, i tombini tracimarono, le campagne si coprirono d’acqua.
Il perdurare del maltempo ebbe effetti catastrofici. Lo scioglimento della neve in alta montagna, provocato dallo Scirocco, incrementò la portata dei corsi d’acqua già in piena, mentre l’Adriatico, sospinto dal vento, si fece minaccioso. Il Tagliamento ruppe gli argini allagando Latisana; i bacini artificiali di Barcis, Redona, Selva e Ciul furono rapidamente saturi e incapaci di contenere le masse d’acqua che giungevano dalle montagne. Nella Destra Tagliamento la situazione precipitò: Morsano, Sesto al Reghena, Prata, Pasiano e Pordenone furono tra i centri più colpiti.
A Pordenone il Noncello uscì dagli argini, invadendo i quartieri di Borgomeduna, Vallenoncello, Villanova e Le Grazie. Le acque raggiunsero piazzetta San Marco, sommergendo la zona tra il ponte ferroviario e il ponte Amman (odierna viale Martelli). Le vie principali furono chiuse, la statale Pontebbana interrotta, il traffico bloccato. L’alluvione del 1966 superò di gran lunga, per estensione e intensità, quella dell’anno precedente: ventimila ettari di territorio provinciale risultarono allagati.
Nelle campagne la situazione fu drammatica. A Morsano al Tagliamento l’argine cedette per ottanta metri: le frazioni di Mussons e Carbona furono sommerse, la popolazione evacuata. A Prata, il torrente Sentiron ruppe nuovamente gli argini; il Meduna allagò Zoppola e Cordenons, mentre il Livenza invase Sacile e le zone limitrofe. In Valcellina le frane isolarono Barcis e Claut, interrompendo ogni collegamento con la pianura.
Il bilancio fu gravissimo. Due giovani vigili del fuoco persero la vita nel capovolgimento del mezzo anfibio su cui operavano tra Maron e Puja. Centinaia di abitazioni furono dichiarate inagibili, numerose industrie – tra cui la Cartiera Galvani e il Cotonificio Veneziano – subirono ingenti danni; migliaia di lavoratori restarono senza occupazione. In molte località l’acqua raggiunse i quattro metri di altezza, trasformando la pianura pordenonese in una vasta distesa fangosa.
Quando il maltempo cessò e tornò il sole, il paesaggio appariva irriconoscibile: il fango seccandosi imbiancava i terreni, le strade e le abitazioni. Gli argini del Meduna presentavano tredici falle, centinaia di capi di bestiame risultavano perduti, decine di stabilimenti produttivi compromessi. Il danno complessivo, nel solo circondario di Pordenone, fu stimato in quaranta miliardi di lire – pari a 405 milioni di euro attuali.
Nei giorni successivi giunsero in visita ministri, parlamentari e autorità locali. Tutti riconobbero la necessità di un intervento strutturale per la sicurezza idraulica del territorio. Nacque così il progetto dei bacini di Ravedis e Colle, lungo il Cellina e il Meduna, pensati per moderare le future piene e ridurre i rischi per la pianura friulana. Tuttavia, i lavori subirono lunghi ritardi e solo il bacino di Ravedis, dopo decenni di sospensioni e rifinanziamenti, venne completato.
L’alluvione del 1966 non fu soltanto una calamità naturale, ma un monito. Essa dimostrò che la sicurezza del territorio non può essere affidata all’improvvisazione né alla buona sorte, ma richiede una politica di prevenzione costante e lungimirante. La memoria di quei giorni, in cui il Friuli vide le proprie terre sommerse e la propria comunità messa a dura prova, resta un dovere civile e un ammonimento per il futuro.
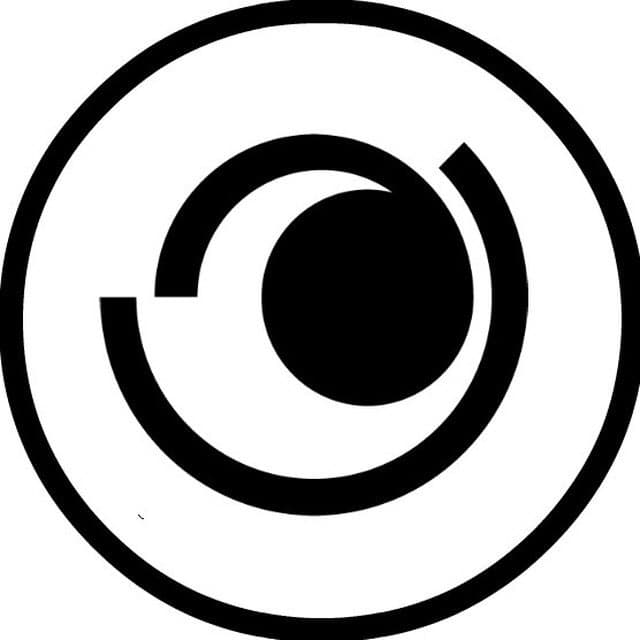
Profilo ufficiale dell’Associazione L’oppure dedicato alla pubblicazione di articoli, comunicati stampa e notizie riguardanti i nostri eventi.

