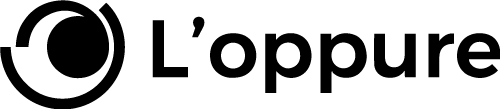Questo articolo non vuole essere uno dei soliti della rubrica Voli sul Territorio. O meglio, vorrebbe esserlo. Vorrebbe descrivere tutte le impressioni ricavate da chi, per la prima volta nella sua vita, ha visitato con occhio maturo il maestoso e imponente sacrario militare di Redipuglia, un complesso unico nel suo genere sia per architettura che per significato. Qui infatti giacciono 100.000 soldati italiani morti durante la Grande guerra del 1915-18, ricordati nominalmente e anonimamente.
Ebbene, con la volontà di vedere dal vivo questo monumento alla memoria e al ricordo di quanti diedero più o meno volontariamente, più o meno insensatamente la vita per l’Italia mi sono recato a Redipuglia, fiducioso di ricavare quelle impressioni di commozione mista a incredulità e rabbia, che solo questi luoghi deputati al ricordo possono dare.
In passato mi ricordo di aver avuto a che fare con un tale, Celio B., un ex studente cafoscarino come me nato esattamente un secolo prima di me, nel 1892, e che al suo secondo anno di università si era arruolato volontario per andare a combattere al fronte. Arruolamento volontario, dalle lettere era così entusiasta di combattere per ciò che credeva. Un illuso? Forse. Ma comprensibile visti i tempi in cui buona parte dei suoi colleghi studenti universitari spasimavano per imbracciare un fucile e affrontare il nemico per liberare Trento e Trieste. Celio, che aveva una passione per l’Italia, aveva una famiglia che lo amava, degli amici con cui si divertiva, un piano per l’università e il futuro. Ma tutto questo si è interrotto bruscamente. Per una pallottola sparata da un fucile così anonimo da rendere anch’egli anonimo, al pari di tanti altri che oggi ricordiamo sinteticamente come i caduti.
Si tratta del mio primo ricordo d’archivio: ho conosciuto l’esperienza di Celio attraverso il suo fascicolo matricolare conservato nell’archivio storico di Ca’ Foscari e mi ricordo che una delle sue ultime lettere era indirizzata alla famiglia e conteneva ancora volontà di combattere e speranze per il futuro. Era stata scritta pochi giorni prima di finire ucciso. Celio rappresenta certamente un caso di minoranza rispetto a quanti poveri disgraziati erano stati costretti a combattere contro la propria volontà con la pena della fucilazione in caso di “codardia”. Ma la sua vicenda mi colpì così profondamente da cambiare radicalmente la visione liceale superficiale che avevo della guerra. Che mi era sì stata insegnata come terribile ma non al punto da farmi comprendere cosa essa fosse stata veramente. A leggere quelle carte d’archivio era come l’avessi vissuta io stesso.

Con questo ricordo in mente, dicevo, sono andato a Redipuglia per visitare il complesso dove riposano i commilitoni di Celio. Ho trovato un monumento lasciato da una parte trascurato, dall’altra chiuso per tre quarti da lavori di ristrutturazione avviati ancora un anno fa, per i quali il Ministero della Difesa dava scadenza di completamento a dicembre 2019. Tralasciando il fatto che non mi è stato in alcun modo possibile raggiungere l’ossario in cima, dove sono sepolti i caduti non identificati, e nemmeno avvicinarmi più di tanto alla tomba del Duca d’Aosta circondata da una recinzione metallica su piede di cemento fatta per restare (mentre è comprensibile la chiusura di una delle due scalinate laterali, ho trovato del tutto illogica la chiusura di entrambe senza poter garantire almeno un percorso alternativo) ho trovato uno scenario di quasi totale abbandono: erba alta e incolta sulle aiuole e sui giardini circostanti e museo chiuso senza indicazioni sull’eventuale riapertura, con aste sul piazzale senza le dovute bandiere della regione, italiana ed europea, quasi fosse un piazzale e un edificio abbandonato.

Ma la cosa che mi ha fatto più impressione è stata la chiusura del Parco della Rimembranza, cito testualmente, “per ragioni di sicurezza“. Violando la banale barriera di ferro tenuta chiusa con un laccetto, sono entrato per capire le ragioni di questo pericolo. Ragioni che stavano nel rischio di ribaltamento di pezzi d’artiglieria d’epoca, ristrutturati nel 2012 (come riportato nella targa all’ingresso del parco), pesanti almeno una tonnellata. Stabilizzati saldamente sul terreno. Di contorno, la stessa incuria, le stesse erbe alte viste nei pressi del sacrario. Il tutto nel contesto di una domenica dove oltre a me c’erano famiglie con bambini, giovani e meno giovani coppie e piccole comitive, venute a vedere il monumento, segno di quanto famoso sia questo posto.

Essendo un luogo deputato alla memoria del sacrificio di centinaia di migliaia di vite non ci si può aspettare tali livelli di incuria e trascuratezza che nemmeno l’emergenza Covid può giustificare. O meglio, può giustificare nel momento dei tre mesi della quarantena di questa primavera, ma non nel momento in cui si verificano aperture per la stagione estiva quasi alla normalità. Specialmente in luoghi aperti. Specialmente quando si deve puntare al massimo sul turismo in previsione dei tempi bui che ci attendono. Specialmente perché lì riposano i nostri antenati, i nostri bisnonni e trisnonni che sacrificarono la propria vita per il Paese, che soffrirono sulle trincee, che compirono immani fatiche per portare un cannone pesante il triplo di loro sulle cime delle montagne e delle colline per togliere al nemico anche solo un metro di terra, con il rischio di finire fucilati alle spalle se non obbedivano agli ordini.
Lasciare al degrado uno dei sacrari più grandi d’Europa non è degno, né dell’umanità, né del ricordo, né dell’idea che tutti noi abbiamo di casa nostra. Non è degno di un popolo che si dice orgoglioso della propria storia.
Pordenonese doc, classe 1992. Dottore di ricerca in Scienze storiche tra l’Università di Padova, Ca’Foscari di Venezia e Verona, mi piace pensarmi come spettatore di eventi che in un futuro lontano saranno considerati storia. Far conoscere al meglio e a quanti più possibile il nostro passato, locale e non, è uno dei miei obiettivi e come tale scrivo con passione per le mie amate Radici.