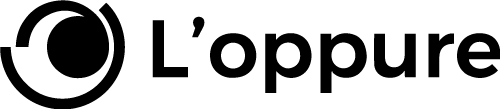Dall’anno 2004 in Italia ogni 10 febbraio viene celebrato il Giorno del Ricordo per rendere omaggio a tutte le vittime delle foibe e delle centinaia di migliaia di esuli italiani che, per le pressioni del regime jugoslavo titino, dovettero lasciare le loro case e fuggire dalle loro terre in Istria, Fiume e Dalmazia. Una vicenda che ha privato queste regioni di un importante elemento storico e culturale e che ancora oggi, essendo terreno fertile di polemiche, lascia tracce profonde nella nostra memoria nazionale.
Caduto il fascismo, a partire dall’8 settembre 1943 la costa e l’entroterra dell’Istria, analogamente al resto dell’Italia del nord, furono teatro del fenomeno partigiano, qui suddiviso non solo per ideologia ma anche per etnia: quello slavo e quello italiano. In particolare l’elemento ribelle croato e sloveno era inquadrato principalmente tra le file del ben strutturato Movimento di liberazione del maresciallo Josip Broz “Tito”, di ideologia comunista e operante in tutta la Jugoslavia occupata; mentre quello italiano nel minoritario e variopinto Comitato di Liberazione Nazionale, operante nelle maggiori città costiere della Venezia Giulia (sebbene alcune frange comuniste di esso già cooperassero attivamente con i titini).
Due componenti etniche che, nel corso della storia dell’ultimo mezzo secolo, avevano avuto molto da ridire tra loro: all’origine dei contrasti vi era la contrapposizione tra i rispettivi nazionalismi iniziata già nella seconda metà del XIX secolo nel contesto dell’allora Impero austro-ungarico. Una contrapposizione inizialmente avviata dagli italiani presenti in maggioranza sulla costa i quali, essendo più avanzati dal punto di vista economico, si ritenevano superiori culturalmente e amministrativamente rispetto agli sloveni e ai croati abitanti le campagne.
Poiché questi ultimi, a livello di popolazione, rappresentavano l’effettiva maggioranza numerica della Venezia Giulia, l‘élite italiana, timorosa di perdere il proprio status di riferimento politico e sociale dinnanzi all’imperatore, guardava con diffidenza gli spazi che l’autorità austriaca concedeva loro.Conseguenza fu un sempre più marcato distacco tra due comunità che nel corso della storia avevano sempre convissuto senza troppi contrasti tra loro.
Dopo la Grande Guerra, annessa all’Italia tutta la Venezia Giulia, se gli slavi presenti entro i confini italiani guardavano con desiderio al neonato Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, da parte italiana il nuovo movimento fascista, dichiaratamente anti-slavo, aveva contribuito ad inasprire questa contrapposizione a favore dell’elemento italofono: l’Istria era solo e soltanto italiana.
Una definizione che andava ribadita con ogni mezzo necessario: polizia e autorità locali chiusero spesso un occhio sulle violenze squadriste ai danni non solo degli antifascisti italiani ma anche dell’intera comunità slava, talvolta assecondandole senza porre rimedio (famoso è l’incendio a Trieste del Narodni Dom, la Casa del Popolo della comunità slovena).
Diventato regime, il fascismo si radicalizzò sempre più su questa questione con provvedimenti mirati a italianizzare di chi non parlava italiano, facenti parte di una politica di snazionalizzazione che comprendeva la chiusura di giornali, scuole, associazioni, sindacati slavi, nonché l’italianizzazione forzata dei cognomi e l’utilizzo della sola lingua italiana nel contesto pubblico. Tutto ciò diede ampio spazio al risentimento di sloveni e croati.
Durante la Seconda guerra mondiale, con l’invasione ed occupazione della Jugoslavia nel 1941 e l’annessione della Dalmazia e della Slovenia meridionale all’Italia, si aprì un nuovo capitolo di violenza: al di là delle persistenti politiche di italianizzazione forzata e della situazione stazionaria in Istria, gli slavi delle recenti acquisizioni e dei territori appena occupati vennero tenuti sotto un più stretto controllo da parte delle autorità italiane.
Esisteva infatti il pericolo che essi, nei villaggi e nelle comunità poste sotto il duro giogo nazifascista, potessero fornire appoggio alla ben organizzata partigianeria, nata in poco meno di un mese dall’invasione italo-tedesca. A tale scopo, la rappresaglia era riassunta nella frase, espressa da Mario Roatta nella Circolare 3C, “testa per dente”: fucilazione di un certo numero di civili slavi, prelevati a forza e a caso dalle proprie case o già presenti nei campi di concentramento italiani, per ciascun soldato italiano morto a causa dei partigiani.
Nell’settembre 1943, successivamente all’armistizio dell’Italia e alla dissoluzione dell’esercito e delle istituzioni italiane, tutta l’impalcatura del terrore fascista venne meno. In Istria seguì allora una prima fase di “caccia alle streghe” ai danni degli italiani dell’entroterra, nella quale morì un numero imprecisato di persone (in ordine di grandezza si pensa circa tra le 500 e 700 vittime).
Con l’appoggio dei contadini croati insorti, le truppe partigiane formarono dei comitati popolari il cui scopo era quello di ripulire il territorio dai “nemici del popolo”, in sostanza da tutti coloro che nell’immediato non erano disposti a collaborare col Movimento di liberazione titino. Primi obiettivi erano quindi gli alti gradi fascisti, seguiti da funzionari minori, come i podestà, segretari e impiegati comunali, carabinieri, ufficiali postali ed esattori delle tasse. Seguivano quindi le persone più in vista, come funzionari e/o dirigenti d’industria e tutte le figure più importanti delle singole comunità, come i liberi professionisti e gli insegnanti.
Nel contesto della guerra si trattava quindi di una violenza politica pianificata dagli uomini di Tito, basata non solo sul risentimento di classe maturato dai contadini e dai mezzadri slavi nei confronti della classe dirigente italiana, ex-dominatrice politica e sociale di quelle terre, ma anche sui risentimenti nazionali e sui rancori etnici, talvolta personalistici, della popolazione.
Era quindi una rivoluzione sia nazionale che sociale: il Movimento di liberazione, di impronta marxista, per mobilitare le masse proletarie slave contro gli italiani fece ampio ricorso alla parola d’ordine della nazione e di conseguenza all’odio inter-etnico.
A titolo d’esempio, i primi quadri comunisti croati in Istria erano figli di esuli croati istriani che erano scappati in Jugoslavia durante il periodo di italianizzazione fascista: rientrati per l’occasione, essi avevano portato con sé, alla formazione del Partito comunista croato, tutto un bagaglio di fortissimo antagonismo nazionale.
In questa prima fase, molti furono quindi gli italiani sommariamente processati e giustiziati mediante fucilazione e/o, legati tra loro con fil di ferro, direttamente gettati in quelle cavità carsiche note come foibe: tra essi anche esponenti antifascisti del Partito Comunista d’Italia, contrari a questa concezione jugoslava di lotta di liberazione.
Una precisazione si rende necessaria: come sappiamo, la Seconda guerra mondiale fu un conflitto totale poiché coinvolse senza distinzione anche i civili, i quali furono al centro di stragi indiscriminate e rappresaglie così tanto frequenti da essere considerate alla pari di una “moneta corrente” tra i contendenti. La guerra di liberazione jugolsava non aveva nulla di diverso nelle modalità del nazifascismo, non fu cioè qualcosa di unico e originale ma ripeteva un fenomeno comune in altri teatri bellici d’Europa in cui le vittime erano essenzialmente gli abitanti delle zone coinvolte.
Tuttavia, secondo lo storico Raoul Pupo, tutte queste violenze anti-italiane in Istria non devono essere giustificate con il pretesto della vendetta degli slavi nei confronti dell’occupazione e della violenza fascista nel conflitto, come ad esempio avvenne tra i russi e i tedeschi nella primavera del 1945.
Questo nesso diretto infatti non esiste: le violenze contro gli italiani in Istria furono nient’altro che una conseguenza del coinvolgimento nel settembre 1943 della penisola istriana, cioè di un territorio fino a quel momento relativamente tranquillo, nella logica della guerra totale, della guerra civile e della guerra di liberazione in Jugoslavia già in atto dal 1941.
Se si vogliono ricercare i motivi di fondo, senza scadere nel giudizio, essi si collocano ben prima guerra, durante il Ventennio e le sue politiche di snazionalizzazione che avevano oppresso ed esasperato la popolazione slava della Venezia Giulia, la quale aveva colto l’occasione di sollevarsi contro gli italiani.
Le sofferenze e le violenze non si fermarono però con la fine del conflitto e andarono oltre il contesto della guerra: occupata Trieste dalle truppe titine, in previsione di una prossima annessione, nel maggio 1945 scattò la seconda fase di persecuzione degli italiani, questa volta incentrata sulle città della costa. Prime vittime furono i collaborazionisti e gli esponenti della Repubblica Sociale Italiana ma anche antifascisti e anticomunisti italiani locali, partecipanti al CLN giuliano che pure avevano dato un deciso contributo alla lotta contro i nazifascisti.
L’ordine era quello di liquidare tutti i poteri armati non inquadrati, potenzialmente ostili all’esercito jugoslavo, assieme ai potenziali oppositori al regime comunista e all’annessione alla Jugoslavia. Circa 5.000 (secondo altri 10.000) italiani solo tra Trieste e Gorizia, di più varia estrazione sociale, vennero arrestati, fucilati, gettati nelle foibe o rinchiusi nei campi di concentramento jugoslavi.
Non vi era però un progetto di espulsione ed eliminazione totale degli italiani in quanto tali: obiettivo principale era quello di punire chiunque si fosse macchiato di qualsiasi colpa nei confronti degli slavi, ripulendo la società da tutti gli elementi ostili o pericolosi, intimidendo tutta la popolazione tramite l’impiego del terrore esercitato dalle foibe. Parole come genocidio o sterminio quindi sono del tutto fuori luogo: sia prima che dopo il 1945 si trattò di un’epurazione preventiva volta a reprimere i “nemici del popolo” in un clima da resa dei conti e di fredda violenza calcolata di Stato.
A testimonianza che questi termini non siano adatti, vi fu una politica di “fratellanza italo-jugoslava” riservata a tutti quegli italiani “onesti e buoni”, i quali, per essere tali, dovevano essere proletari, comunisti, e pro-annessione alla Jugoslavia. Una politica questa, riguardante circa un terzo della popolazione italofona, che durò fino alla rottura tra Tito e Stalin nel 1948, quando i comunisti italiani, favorevoli al leader sovietico, vennero considerati a loro volta nemici del popolo e quindi cacciati o internati.
Il regime, socialista e nazionalista insieme, ebbe quindi carta bianca per rivoluzionare tutto il contesto socio-culturale giuliano: la cultura e la società italiana vennero di conseguenza derise e umiliate, anche violentemente, di pari passo con la proibizione dell’uso pubblico e dell’insegnamento dell’italiano.
Due erano le possibili soluzioni che si prospettavano agli italofoni: adeguarsi al nuovo regime o andarsene. In molti, perso il posto di lavoro assieme la loro posizione e considerazione sociale, maturarono quindi, in un clima di ostilità sempre più evidente e pressante, la difficile decisione di partire.
L’esodo fu il capitolo conclusivo. A partire dal 1947, circa il 90% degli italiani furono costretti ad abbandonare tutto ciò che possedevano per mettersi in salvo. Una marea di profughi che in Italia fu accolta in maniera tiepida, se non freddamente: erano stranieri in patria, non considerati italiani, spesso reputati dagli ambienti di sinistra del PCI come fascisti in fuga dal paradiso socialista jugoslavo e pertanto insultati e/o oggetto di violenza.
Tra il 1947 e il 1954 città di antica tradizione latina, veneta e poi italiana, quali ad esempio Rovigno, Pola, Fiume e Zara, si trovarono di colpo svuotate dal maggioritario elemento autoctono italofono e vennero quindi ripopolate con elementi slavi provenienti dall’entroterra istriano e balcanico.
Per approfondire suggerisco:
R. Pupo, R.Spazzali, Foibe, Milano, Mondadori, 2003;
P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana, I, Partenze, Roma, Donzelli, 2001;
M. Cuzzi, G. Rumici, R. Spazzali, Istria-Quarnero-Dalmazia. Storia di una regione contesa dal 1876 alla fine del XX secolo, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2009.
Pordenonese doc, classe 1992. Dottore di ricerca in Scienze storiche tra l’Università di Padova, Ca’Foscari di Venezia e Verona, mi piace pensarmi come spettatore di eventi che in un futuro lontano saranno considerati storia. Far conoscere al meglio e a quanti più possibile il nostro passato, locale e non, è uno dei miei obiettivi e come tale scrivo con passione per le mie amate Radici.