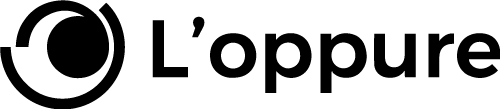Olimpiadi di Pechino, 2008. Samia Yusuf Omar si prepara a correre i duecento metri piani; non ha mai visto così tanta gente ad una sua gara in Somalia, non ha neanche mai provato quei blocchi metallici su cui tutte le avversarie si stanno posizionando per la partenza. Le vede appoggiare i palmi delle mani, poi i piedi. Per imitazione, si abbassa anche lei; intorno è tutto uno strepitare, un applaudire: bandiere che sventolano, sguardi che le fissano. E poi, improvvisamente, tutto tace: lo starter spara. Samia inizia a correre, veloce, più che può: è la più esile, lì, tra tutte, con le sue gambe magre e il viso ancora da ragazzina; porta una semplice fascia bianca sulla fronte, mentre all’avanzare dei metri percorsi aumenta anche il distacco dalle altre atlete.
Samia, facendo il suo miglior tempo, arriva ultima: 32”16. Mentre Michael Phelps aggiunge al suo medagliere l’ennesimo oro, Usain Bolt stabilisce il nuovo record del mondo e Federica Pellegrini conquista il gradino più alto nei 200 metri stile libero, la conquista di Samia Yusuf Omar è visitare per la prima volta un paese dove non c’è la guerra. Samia si allontana dall’odore delle bombe appena esplose, dal rumore assordante dei mitra, dagli occhi disperati dei bambini rimasti orfani. Si allontana per poco, perché quel 32”16 non è sufficiente per cambiare vita: Veronica Campbell Brown vince con 21”74, la penultima con 25”32; lei con 32”16. Eppure per Samia vuol dire tanto, per una ragazzina di Mogadiscio è tutto: quando torna a casa, ricomincia ad allenarsi tutti i giorni, costantemente, col sogno di essere vista da qualcuno e andare alle Olimpiadi di Londra. Samia sogna, come tutti i ragazzi, lei crede, ma la realtà frantuma le sue speranze sbattendole contro al muro dell’evidenza: Samia è donna, è somala e non ha documenti. Non ha documenti, è somala, è donna. È donna. Sembra un dato irrilevante per la nostra mentalità occidentale, dove la figura femminile sta raggiungendo traguardi importanti, ma il fatto che qui la donna intraprenda un viaggio da sola, stia tra gli uomini e scelga il suo futuro, non è scontato altrove. Di certo non in Somalia, dove alla richiesta di Samia di un allenatore tutti la ignorano. Samia, però, sa di tutte quelle persone che salpano e arrivano in un paese in cui viene dato più adito ai propri sogni.
Emigrare per lei è l’unica soluzione, l’ultima: dopo aver toccato Etiopia, Sudan e Libia, il barcone su cui stava Samia naufraga nel Mediterraneo. Samia muore annegata, insieme a tante altre persone, il 2 aprile 2012. Oggi siamo nel 2017, ma la situazione non sembra essere migliorata: ci si ricorda delle vittime della società solo quando se ne sente parlare alla televisione o in radio, per il resto è conveniente non pensarci; le guerre, il potere di alcuni stati, l’arricchimento di pochi a discapito dei molti, sta danneggiando in maniera irreversibile questo pianeta su cui viviamo. A volte ci si dimentica di tutte quelle persone che senza averne colpa vengono eliminate da una situazione più grande di loro, come pedine di un gioco mostruoso e fuori controllo.
Sono ormai una cifra altissima quelli che lasciano la propria vita in cerca, come Samia, di una condizione migliore, in cui esaudire i desideri, dal giocare in un prato di fiori, al dormire serenamente, al partecipare alle Olimpiadi. Eppure molte di quelle nuove vite sognate rimangono soffocate dall’infrangersi delle onde del mare, quel mare nostrum sempre più pieno di anime spente, alla deriva, e occhi rimasti a guardare la Luna mentre l’impotenza li calamitava sul fondo. Decine di bambini, giovane donne e uomini, morendo in mare, bombardati nelle loro case, fucilati da nemici di cui non conoscono nemmeno il volto, la voce, sono diventati lo specchio della realtà intollerabile in cui ci troviamo. Gli attuali eventi tragici, che esigono una soluzione tempestiva, non possono portarci a vedere l’ennesimo barcone affondato come una cosa normale, perché non lo è. Se oggi ci troviamo in una situazione del genere è perché qualcosa non funziona nella nostra società in cui, probabilmente, manca in ciascuno di noi il senso di appartenenza a quella grande classe che unisce bianchi e neri, alti e bassi, belli e brutti, tutti diversi tra noi, ma con lo spirito di comunità umana.
Il filosofo greco Aristotele sosteneva che l’uomo, oltre a differenziarsi dall’animale per la ragione, ha la naturale tendenza ad essere socievole, cioè a vivere in comunità. Questa sua appartenenza lo porta a sentire una sorta di dovere morale nei confronti del gruppo a cui appartiene, a fare bene non solo per sé, ma anche per gli altri. Ecco, probabilmente ciò che è necessario adesso è allargare il concetto di “comunità” dalla propria nazione, o cerchia sociale, ad una visione più globale che comprende tutti gli esseri umani. Niente razzismo, niente pregiudizi, niente lotte per la supremazia. Sì, caro Aristotele, questo ragionamento potrebbe funzionare. Peccato che in considerazione bisogna tenere anche l’egocentrismo dell’uomo, una caratteristica intrinseca alla sua natura e impossibile da sopprimere. Quindi, Samia, scusa la nostra arroganza, la tua unica colpa è aver sognato qualcosa di troppo grande per questo mondo.