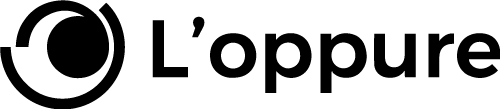Nell’immaginario collettivo, il lavoro del fotoreporter è un gran bel mestiere:viaggi spesati in ogni parte del globo, bei posti e buone compagnie, discreti guadagni e se una foto è bella ci scappa il Premio Pulitzer. Non sempre è così.
Perchè c’è foto e foto: la foto di uno strano fenomeno atmosferico, o quella di una strada caratteristica di una città asiatica, possono essere gradevoli o meno a seconda della bravura del fotografo. Ma non sono foto che rimarranno nella memoria collettiva, perchè chi le fa si limita a immortalare una parte del mondo nel momento giusto. Le foto destinate a rimanere nella storia son quelle che hanno al centro l’essere umano. E qua sta un’ulteriore divisione: perchè fotografare il bello dell’essere umano ( Le modelle delle sfilate di moda più chic, gli atleti in gara durante le olimpiadi,..) può essere difficile ma dal punto di vista puramente tecnico; quando invece si cerca nel peggio dell’essere umano, come nelle guerre o nelle carestie del Terzo Mondo, ci vuole anche un po’ di solidità mentale. Se non ce l’hai, non riesci: perchè per combattere i mostri dell’umanità, rischi di rimaner vittima dei mostri della mente.
E’ l’Otto Giugno 1972: in Vietnam impazza uno dei conflitti più lunghi e sanguinosi del’900; quella mattina, un minuscolo villaggio nel sud del paese viene bombardato dalle truppe USA: vengono sganciate bombe al Napalm incendiario. i sopravvissuti fuggono spaventati e ustionati. Fra di loro, una bambina totalmente nuda, che corre e piange. IL reporter Nick Ut, arrivato nei pressi del villaggio quasi per caso, immortala la scena: quello scatto, che li valse il premio Pulitzer, viene ricordato come “The Napalm Girl”, ed è la foto simbolo del conflitto. Eppure Ut è ambivalente sulla foto: ne va orgoglioso, ma ne parla come se il merito fosse soprattutto della bambina, ancora oggi vivente, “prova eloquente dell’autenticità della foto e degli orrori della guerra”. Ut oggi lavora per la Associated Press, ma non ha piu’ parlato di guerra: il ricordo è forse troppo forte? Almeno lui si fermò in tempo, al contrario di Kevin Carter.
In pochi lo conoscono, ma è sua la foto simbolo del XX° secolo: fu scattata nel marzo1993 in Sudan, dove Carter, Sudafricano bianco e già attivista anti-apartheid, si trovava per documentare una delle carestie peggiori di sempre, di fronte alla quale un governo corrotto rispondeva aumentando la spesa militare. e qui, Carter immortala una scena di una crudezza pazzesca: una bambina di circa cinque anni, scheletrica e zoppa, che si accascia al suolo in fin di vita; dietro, un’avvoltoio sembra aspettare la morte di quello che diventerà il suo pasto.
Carter con quella foto vinse il premio pulitzer 1994, ma si rovinò: nel giro di poche settimane entrò in depressione, poi cominciò a drogarsi, e infine, il 27 luglio 1994, si tolse la vita inalando monossido di carbonio. Schiacciato dal rimorso di non aver potuto salvare quella bambina. Sconfitto dai mostri della mente, dopo aver dato un contributo a sconfiggere i mostri dell’umanità.

Mi chiamo Giulio Pellis, nato a Pordenone il 3 giugno 1994, mi sono diplomato al liceo classico e oggi studio economia all’ università di Udine. Sono attivo nell‘ambito dell‘attivismo politico a livello regionale, mi piacerebbe molto diventare giornalista e con la scusa del lavoro girare il mondo in lungo e in largo.