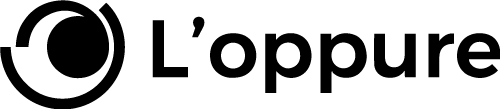Prima che iniziate questo articolo, una premessa è doverosa. Non appena avrete finito di leggerlo, se ancora non avete visto il film, cercate su internet altre recensioni, e leggetene una a caso. Probabilmente inneggerà al capolavoro assoluto. Chi scrive, diciamolo subito, è di opinione differente. È entrato in sala con grandissime aspettative e ne è uscito con un senso di vuoto e smarrimento, come chi è stato deluso dal suo migliore amico. Ogni recensione è in fondo niente di più che una opinione strettamente personale, e l’unica giusta è quella che voi stessi vi farete.
Veniamo al film, dunque. Che storia è quella che ci viene raccontata? La costruzione corale di un film come Magnolia ha lasciato qui il posto al racconto di un uomo solo e dei suoi demoni interiori.
Siamo nella Londra degli anni ’50. Un Daniel Day-Lewis di crepuscolare grandezza veste i panni di Reynolds Woodcock, celebre sarto che confeziona abiti su misura per le signore dell’alta società londinese, e non solo. Il suo stile unico e inimitabile è frutto di una dedizione al lavoro maniacale, che assorbe tutto il suo essere. Reynolds viene descritto come un uomo esigente; nei confronti della stoffa con cui si misura ogni giorno; nei confronti delle donne che indossano i suoi vestiti e devono dimostrarsene degne; nei confronti di se stesso, prima di tutto il resto. Reynolds conosce alla perfezione le donne, il loro corpo, le loro misure. Non altrettanto bene la loro anima.Tutto cambierà il giorno in cui incontrerà Alma – grande interpretazione di una poco conosciuta Vicky Krieps, che forse avrebbe meritato una nomination? – una giovane cameriera che entrerà dapprima nei suoi abiti e poi nella sua vita, stravolgendola completamente.
Ci sono molti modi di entrare nella vita di un’altra persona. Si può farlo con la delicatezza con cui si taglia una striscia di stoffa, oppure come un uragano che distrugge e ricostruisce nuovi equilibri. O a volte in entrambi i modi.
C’è un antico detto gitano che sostiene che il primo che dice ti amo perde. Tutta la pellicola è incentrata sulla relazione che si instaura fra Reynolds e Alma – non c’è una scena in cui uno dei due non sia presente sullo schermo –, sul duello che mettono in scena e sull’inesausto tentativo di aprirsi all’altro pur mantenendo le proprie difese, tentativo che costituisce in fondo ogni storia d’amore.
Tutto lo sforzo di Alma consiste nello spostare l’attenzione di Woodcock dagli abiti che indossa a se stessa, al corpo vivo che si cela sotto di essi.
Dal punto di vista formale, è un film ineccepibile. Paul Thomas Anderson, si sa, ha una cura maniacale per i dettagli, che unita a una padronanza assoluta della macchina da presa rende questo film un capolavoro dell’estetica. Lo testimonia una ricerca insistita del primo piano e del dettaglio, cifra stilistica della fotografia firmata, per la prima volta in carriera, dal regista stesso. Le scenografie e i costumi sono memorabili. Ma la sensazione forte è che questa estetica sia soverchiante e avvolga il racconto come un serpente nelle sue spire, fino a soffocarlo. E non basta a salvarlo un finale sicuramente potente, ma che vedi arrivare da lontano e a cui ti avvicini lentamente, come una nave che avvista il profilo di un continente molto prima di approdare a terra.
L’etimologia della parola trama rimanda proprio all’atto della tessitura, dell’intrecciare fra loro eventi diversi che, come tanti fili uniti fra loro, confezionano l’abito di una storia. In questo film, la sensazione è che le stoffe pregiatissime (le immagini ricercate) non siano tenute insieme da una trama all’altezza. In questo modo la perfezione estetica finisce per diventare un mero esercizio di stile.
In ogni storia che funziona c’è un filo nascosto, che è quello che tiene il pubblico agganciato dall’inizio alla fine. È quello che manca a questo film.
Intendiamoci: chi pensa che il cinema sia prima di tutto un vizio di forma, amerà questo film. Chi invece ancora va al cinema per cercare quelle emozioni che solo una bella storia ben raccontata è capace di dare, come il sottoscritto, corre il rischio di uscire dalla sala insoddisfatto.
Oggi il cinema sta diventando sempre di più un regno dell’estetica pura, di pellicole attente prima di tutto alla forma, come se fosse l’unica cosa che può ancora giustificare l’esistenza del grande schermo in un epoca in cui ognuno di noi ha uno schermo in tasca; e la narrativa trova il suo luogo ideale nella lunga narrazione delle serie.
In un panorama simile, chi ancora crede nel cinema come forma di epica moderna, che raccontava prima di tutto le grandi storie, e insieme come opera d’arte totale capace di armonizzare al suo interno tutte le forme d’arte della grande cultura europea, narrativa inclusa – narrativa che doveva andare incontro alla difficoltà di sottomettersi a dei canoni rigidi e precisi, il limite temporale in primo luogo, che pure la spingevano a togliere il superfluo fino a raggiungere la sua forma più perfetta (cosa che certamente le serie tv non fanno) – sarà ormai abituato a uscire dalla sala con questo senso di insoddisfazione. Forse è un problema suo. Forse uno spettatore come questo – per usare le parole di Sergio Leone, un regista che credeva nel cinema come moderna forma di mito – appartiene a una razza vecchia.
Articolo di Giacomo Taggi originariamente apparso su Cogito et volo

Ideato per andare oltre la superficie, Cogitoetvolo è uno spazio comune di approfondimento, riflessione e confronto costruittivo riguardo ai temi dell’attualità, del mondo giovanile e delle espressioni artistiche, come cinema, musica, letteratura e teatro. Un blog per giovani protagonisti.