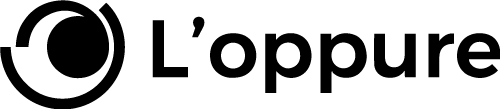È meraviglioso scoprire che dietro una parola si celi un universo inimmaginabile di significati. Pensiamo, ad esempio, alla parola “esule”, oppure ai termini “straniero”, “immigrato”, “clandestino”. Parole che ci conducono rapidamente al concetto di immigrazione ma che dietro serbano una storia etimologico-letteraria di grande fascino e attualità.
Facendo un salto indietro nel tempo, a circa 2000 anni fa, scopriamo, infatti, che anche Ovidio, poeta famoso per la sua Ars Amatoria (e non solo) e tanto celebrato in quegli anni, fu relegato a Tomi (odierna Costanza, in Romania), remota e incolta cittadina sul Mar Nero.
Il poeta latino divenne ben presto uno straniero fra uomini e donne, in un clima differente, in un luogo isolato, dai costumi diversi e dalla lingua “barbara” (come la definivano i romani).
Grazie alle descrizioni riguardanti il suo esilio, riusciamo a dipanare un filo intricato che attraversa i temi dell’exilium, dell’estraneità e della diversità culturale. E ci rendiamo conto che quanto successe al poeta di età augustea non è poi così distante da quel che accade oggi ai migranti africani.
Come dice Cicerone (Pro Caecina, 100) l’esilio è un “cambiar suolo”, è trovare una nuova terra, è riuscire a convivere con le sue contraddizioni e le sue leggi.
“L’esilio infatti non è una punizione, ma uno scampo e un rifugio dalla punizione. Infatti si “muta suolo” (solum vertunt) allorché ci si vuole sottrarre a una qualche pena o disgrazia, è per questo che si cambia sede e luogo. Pertanto non si troverà mai nelle nostre leggi, come accade invece in altre città, che un qualche reato sia punito con l’esilio; al contrario, quando gli uomini vogliono sottrarsi alla prigione, alla morte o alla vergogna, com’è stabilito dalle leggi, essi trovano rifugio nell’esilio come presso un altare”.
Andare in esilio significa, dunque, fuggire dalle angherie politiche, economiche, sociali del proprio Paese. Equivale a cambiar suolo, cambiare abitudini, correre un rischio. Sì, anche la fuga è un rischio, un rischio che mette a repentaglio la vita e che si alimenta, poi, di ulteriori, innumerevoli rischi prima dell’approdo (se si è fortunati) al fatidico “altare”.
Dare il giusto peso a questi aspetti ci renderebbe più comprensivi, tolleranti, più umani nei confronti degli esuli. Ricorderemmo, ad esempio, che anche i nostri conterranei, i nostri nonni e bisnonni un tempo sono stati stranieri, scopriremmo che adesso, magari, lo è qualcuno di noi e che un giorno “straniero” lo sarà uno dei nostri figli.
Per cui provare solo ad immaginare che quanto vissuto da Ovidio nell’anno 8 d. C. accomuni tanti e tanti migranti attuali è già, di per sé, un’occasione di apertura e accoglienza.
Eppure nell’animo del poeta de Le metamorfosi si faceva strada anche un’altra preoccupazione: perdere la propria lingua materna. E perderla significava perdere se stessi.
Credo che la sua paura aderisca perfettamente alla nostra o a quella di chiunque si senta costretto ad utilizzare un’altra lingua disimparando la propria.
“A volte mentre cerco di dire qualcosa (mi vergogno a confessarlo) mi mancano le parole, ho disimparato a parlare. Sono circondato da suoni traci e sciti […]. Credimi, ho paura che nei miei carmi ci siano parole pontiche, e che tu le legga”, (Tristia, 3, 14, 45, sgg).
Ancora una volta il mondo romano disegna sotto i nostri occhi un altro dei drammi vissuti dall’esiliato del mondo contemporaneo: il terrore di perdere, attraverso la propria lingua, direttamente se stessi.
Così Ovidio finisce per ricordare a ciascuno di noi il valore delle nostre radici, la concretezza del binomio accoglienza-identità, e che, in fondo, ospitare uno straniero è come abbracciare insieme la sua e la nostra storia.
Articolo di Domenico Cassese originariamente apparso su Cogito et volo

Ideato per andare oltre la superficie, Cogitoetvolo è uno spazio comune di approfondimento, riflessione e confronto costruittivo riguardo ai temi dell’attualità, del mondo giovanile e delle espressioni artistiche, come cinema, musica, letteratura e teatro. Un blog per giovani protagonisti.