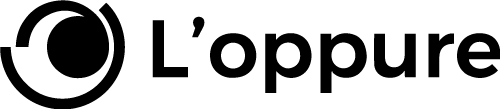Riecheggiano i rintocchi di una campana funebre. È la campana dell’Europa quella che suona, di fronte allo spettacolo tetro di un carro identico a quello che trasportò i feretri degli eredi al trono d’Asburgo quel lontano 1 luglio 1914, quando dall’allora Piazza Grande furono portati alla stazione per proseguire verso Vienna. Gli astanti non potevano sapere che quello a cui stavano prendendo parte si sarebbe trasformato, nei cinque anni a seguire, in un corteo funebre di ben più larga portata.
Il Museo della guerra per la pace Diego de Henriquez offre un primo impatto forte: già in ingresso spiccano due imponenti piastre metalliche trapassate chirurgicamente da una cannonata. Inaugurata in occasione del centenario della Grande Guerra, l’esposizione di reperti bellici raccolti meticolosamente dal triestino Diego de Henriquez (1909-1974) occupa con rigorosa perfezione uno degli edifici dell’ex Caserma “Duca delle Puglie”. Oggi la sala è deserta, pulita e bianca sotto le lampade al neon: gli oggetti parlano da soli. Solo i rintocchi di campana seguono il mio turbato girovagare.
L’estrema chiarezza espositiva non manca di pormi di fronte alla mia ignoranza: quante cose ho dimenticato, date, alleanze, battaglie. Allo stesso modo, quanto ignoro riguardo alle forze in gioco nel mondo di oggi. Una cosa mi sembra importante: come noi hic et nunc evisceriamo con tanta precisione le tensioni che centodue anni fa condussero alla Prima Guerra Mondiale, con la medesima oggettivazione dovremmo cercare di leggere il mondo oggi, assumendo quello che lo psichiatra americano Eric Berne chiama il “punto di vista marziano” nei confronti della situazione. Chiedendoci, nelle piccole scelte come nei grandi accordi tra Stati, dove stiamo andando a parare e se non siamo forse già passati di qui.
Mi sembra che il rischio non sia tanto quello, spesso millantato dalle migliori professoresse, di dimenticare (da cui tutte le giornate dedicate alla memoria): dimenticare fisicamente e collettivamente la mole di informazioni che possediamo oggi riguardo al passato sarebbe impossibile anche per il più lavativo degli studenti. Il rischio vero mi sembra sia quello di ricordare con superficialità e distacco, di scindere tra loro il passato e il presente e le leggi che li governano, che sono le stesse. Le dinamiche sono le stesse. Siccome non esiste immunità all’orrore, non mi sembra che possiamo permetterci il “lusso evolutivo” di scindere il presente dal passato e ritenerci immuni ad orrori nuovi in virtù del fatto che “qui in Europa” ne abbiamo già vissuti di vecchi e le cose ora hanno apparentemente mutato aspetto.
Le grandi foto esposte testimoniano che noi eravamo migranti, soldati feriti, comandanti esaltati dal brivido del potere. Noi siamo stati orfani, vedove, cannibali, vincitori esausti, cadaveri dilaniati. Oggi tutto questo non si vive più quotidianamente nelle nostre vecchie terre stanche (e quando accade, come in recenti tragici fatti di cronaca, per la maggior parte di noi si tratta di un’eccezione, una sventura, un’ingiustizia che ci viene perpetrata da un nemico lontano e inafferrabile), ma sarebbe una menzogna negare che oggi l’orrore non si viva in altre forme, a volte più subdole, oppure appena fuori dalla porta di casa ma – come si dice? – occhio non vede, cuore non duole.
Probabilmente Diego de Henriquez rimuginava qualcosa di simile mentre setacciava con lo sguardo la nebbia di un campo di battaglia abbandonato da non troppo tempo, alla ricerca di qualche rottame da portare a casa per far vedere alla gente che non era mai stata in un posto simile cosa significa, in parole spicciole, la guerra. Nonostante vestisse la camicia nera, la profonda dedizione culturale e l’intento divulgativo valsero da passepartout a questa personalità eccentrica presso i più vari schieramenti, al fine di raccogliere dati, scattare fotografie e collezionare reperti.
Dopo l’8 settembre 1943, de Henriquez collaborò con l’occupazione tedesca di Trieste. Poi, durante la liberazione da parte degli alleati, non solo gli fu concesso di restare in città e documentare fotograficamente l’evento (italiano fascista in mezzo a truppe titine e neozelandesi), ma rivestì anche il ruolo chiave di interprete e negoziatore, recandosi di persona a trattare con l’ultimo gerarca nazista asserragliato nel Palazzo di Giustizia di Trieste. Ne guadagnò qualcosa: in una clausola della resa era specificato che le armi tedesche (e, secondo la tradizione, anche la giacca dell’ufficiale tedesco) venissero affidate alla sua collezione.
L’ultima sezione del Museo, “La guerra come gioco”, è forse la più importante, nonostante raccolga i reperti meno eclatanti: soldatini di piombo, di carta, armi giocattolo del secolo scorso ordinatamente allineati dentro teche di vetro.
“Il soldatino di piombo è il Giuda che voi stessi portate dentro casa, è il tradimento della vita umana! […] Il piccolo elmetto di carta un giorno sarà l’elmetto d’acciaio sulla testa di un assassino! E se il bambino aveva una volta fatto pratica con la pistola giocattolo, com’è naturale che negli anni a venire egli spari con un fucile! […] Voi genitori che non desiderate che i vostri figli uccidano gli amati figli di altri genitori, voi dovreste ricordare che il bambino da cui vi presentate con un elmetto e una spada e una pistola piega giocando la propria tenera anima alla morte […].”
(da War to war!, di Ernst Friedrich)
La conoscenza e la consapevolezza del passato, che congiunte potrebbero essere definite come una delle più grandi “riserve evolutive” della nostra specie (a cui sono perciò legati il nostro adattamento futuro e la nostra sopravvivenza), costituiscono per la collettività una sorta di preziosa “memoria procedurale” già acquisita, proprio come per lo sviluppo di un bambino è importante il ricordo di quella volta in cui ha addentato il gelato troppo in fretta e per un attimo ha visto le stelle. L’ultima sezione, dedicandosi al ruolo fondamentale dell’educazione, sottolinea il fatto non banale che prima di ogni esercito, prima di ogni nazione, movimento politico, associazione a delinquere ci sono i singoli uomini, e prima ancora dei singoli uomini ci sono i singoli bambini, i quali non vedono l’ora se non di giocare a qualcosa.
“Stefano, figlio mio, ti regalerò fucili. Perché un fucile non è un gioco. È lo spunto di un gioco. Di lì dovrai inventare una situazione, un insieme di rapporti, una dialettica di eventi. Dovrai fare pum con la bocca, e scoprirai che il gioco vale per quel che vi inserisci, non per quel .che vi trovi di confezionato. Immaginerai di distruggere dei nemici, e soddisferai a un impulso ancestrale che nessuna barba di civiltà riuscirà mai ad ottenebrarti, a meno di far di te un nevrotico pronto all’esame aziendale attraverso Rorschach. Ma ti convincerai che distruggere i nemici è una convenzione ludica, un gioco tra i giochi, e imparerai così che è pratica estranea alla realtà, di cui giocando ben conosci i limiti. [..] sarà importante, anzi, che morte e distruzione ti appaiano per sempre dati di fantasia, come il lupo di cappuccetto rosso, che ciascuno di noi ha odiato senza che di qui sia nato un odio irragionevole per i cani lupo. […] E ti insegnerò a giocare guerre molto complesse, in cui la verità non stia mai da una parte sola […].Ma se per avventura, quando sarai grande, vi saranno ancora le mostruose figure dei tuoi sogni infantili, le streghe, i coboldi, le armate, le bombe, le leve obbligatorie, chissà che tu non abbia assunto una coscienza critica verso le fiabe e che non impari a muoverti criticamente nella realtà.”
(da Diario minimo, di Umberto Eco)

Nata a Pordenone nel 1993, attualmente studio Medicina e Chirurgia all’Università di Trieste. Per il futuro, sono orientata verso la specializzazione in Psichiatria: oltre all’interesse “didattico” per tutto ciò che riguarda la mente (neuroscienze, psicologia, antropologia), credo fermamente nella necessità di sviluppare, a livello sociale, una “cultura della psichiatria” e di tutto ciò che vi gravita attorno. Nonostante il poco tempo libero (anzi, forse proprio per questo motivo) cerco di mantenere vivo l’interesse per alcune cose belle: i libri, i cani, la musica (canto nel Coro Oberdan di Trieste), i viaggi e, da tempi recenti, lo yoga.