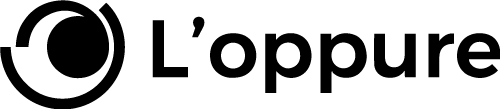Nablus, Cisgiordania: non il posto migliore se si è in ritardo. Sto cercando di farmi strada nel suq del centro storico, inciampando nei carretti del mestierante di turno, tra le bancarelle di frutta e verdura, chi mi grida “welcome to Palestine” e chi mi offre da mangiare, un caffè, le macellerie espongono teste mozzate di mucche e pecore (non c’è trucco e non c’è inganno, non vi mangerete carne di pipistrello). Rabbrividisco, ma è affascinante, l’oscenità del vero… mi giro a guardare di nuovo e quasi vado a sbattere contro l’ennesimo carretto di banane.
Usciti dal centro storico si arriva al centro moderno, ad-Dawar, dove c’è una delle tante stazioni dei taxi: un cubo di cemento sotterraneo su cui si esibisce un magnifico centro commerciale. La stazione è divisa in varie zone, in ognuna delle quali si raccolgono i taxi diretti in un luogo specifico. Come al solito, sto andando a Balata, il più grande campo profughi palestinese in Cisgiordania. Insegno in una scuola materna, oggi per l’ultima volta.
“A’al mukhayyam Balata”, e il tizio annuisce, mi squadra, mi indica il taxi da prendere. Due shekel (mezzo euro a farla grossa), aspettiamo che il taxi si riempia e ci avventuriamo nella giungla di macchine strombazzanti. Il tassista è particolarmente gioviale oggi, mi chiede cosa faccio, da dove vengo, poi all’arrivo mi offre il caffè dal suo amico, un tizio che spunta fuori dal nulla. Italia, dico, lui sorride sdentato e mi snocciola i suoi “Ciao como estai”, lui è di Nablus, ma sua sorella vive a Balata, nel campo profughi, con il marito e i loro sette figli, mi invita a casa loro. Ora non posso, ma ci diamo appuntamento due ore dopo, nello stesso posto.
Oggi ultima lezione di musica, ieri ultima di inglese. Ieri abbiamo finalmente finito le lettere dell’alfabeto. Oggi cantiamo una canzone sugli strumenti musicali: cerco di imbastire una pseudo spiegazione in arabo, loro non mi capiscono, ma ripetono ciò che faccio io, e tanto basta, più gridate, più convinti siete, meglio verrà. La bambina nell’angolo non parla molto, anche oggi ha un livido in faccia. Ma sembrano stare tutti bene, la mia orda di cinquenni scalmanati: non sembrano usciti da questo luogo malsano, dove la notte si popola di spari e di odore di gomma bruciata. Quanto a me, io mi accontento dei postumi la mattina dopo. La mattina mi accolgono fori di proiettile che ieri non c’erano, e carcasse di pneumatici, a marcire sull’asfalto della via principale del campo.
Ogni tanto è pericoloso andare, e noi non andiamo. Ma in generale, noi volontari non corriamo rischi: siamo fuori dai giochi, arbitri imparziali, siamo in buoni rapporti con tutti. Da tre mesi a questa parte vengo qui al campo ogni mattina, quattro volte alla settimana. Adesso quasi mi ci sento a casa, anche se ciò che questa gente vive non mi apparterrà mai. A me spettano i sorrisi di benvenuto, le storie raccontate, il caffè al cardamomo: mai le urla, le botte, il gas lacrimogeno. Chi contro chi, non è più importante, conta solo il conflitto; e allora penso che sì, accoglierò l’invito del mio tassista. Essere accolto a casa di chi non ho mai visto prima, dopo tre mesi di Palestina, non mi stupisce neanche più. Accoglierò l’invito, voglio conoscere la sorella, suo marito e ognuno dei sette figli, perché so che è la sola cosa da fare; ascoltare queste voci dimenticate.

Sono nato a Pordenone nel 1993. Mi divido tra musica e lettere; gli studi classici, la scrittura e le lingue straniere, si accompagnano a pianoforte, chitarra, voce e teatro. Mi interesso di geopolitica e diritti umani e già mi sono imbarcato in varie esperienze di volontariato, soprattutto in Palestina.