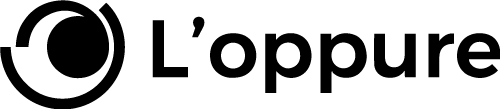Qualche giorno fa sono stato invitato a cena a casa di un amico. Era tornato da un periodo a Nablus, in Cisgiordania, e la conversazione non poteva che rotolare dalle parti di doganieri israeliani e tassisti palestinesi. Bevevamo vino rosso da quei bicchieri che ricordano la sincerità senile delle osterie nei venerdì sera di novembre e, come spesso succede, pensavo a me stesso come a un perfetto campione di 20-e-qualcosa-enne progressista che legge Internazionale, ascolta Mannarino e quando pensa a un Impero pensa agli Stati Uniti e alle loro cose in Sudamerica, in Indocina e in Medio Oriente.
Al dolce, il video di una protesta antigovernativa avvenuta nel 2011 a Hama, una città sul baricentro della direttrice Damasco-Homs-Aleppo: una ciurma pacifica, colorata, quasi in festa.
Premetto che alle manifestazioni non ci vado: mi sembrano sempre troppo rancorose, spesso organizzate da qualche irriducibile del PCI con l’unico scopo di provare a ricordare che sapore avesse la partecipazione politica. E poi non mi piace sentire gli AC/DC sparati a tutto volume da un impianto ruvido di decenni. Non hanno altra funzione se non fare casino e disturbare l’ascolto dell’angelus alle vecchine dei palazzi vicini. Però mentre guardavo quel video ho pensato che mi sarebbe piaciuto essere presente per fare qualche foto, diluirmi nella folla, cercare di afferrare il testo, poi chiacchierare ai margini del corteo con un certo mio coetaneo. Avremmo forse discorso degli Assad e della triste sorte della sinistra secolare in Medio Oriente, gli avrei lasciato il mio numero o ci saremmo tenuti in contatto con Facebook.
“Freedom is at the door / Time to leave, Bashar / Get out Bashar!”: la dabke non eccedeva la sola ingiunzione, il Basta, solo, Ba’ath, basta Assad, e suonava come un capolinea fisiologico del processo di liberalizzazione che stava montando in Siria già dai primi Duemila. In effetti, quella manifestazione era come vorrei che fossero anche le nostre: una dichiarazione collettiva di unità di vedute in cui non è possibile indovinare rancore. Ecco: qualche migliaio di persone che si trovano in piazza. Basta, solo, Ba’ath, basta Assad.
Il video era finito. Ho percepito sincero fastidio nel ricordare una recente scoperta, l’introduzione all’edizione 1999 della guida alla Siria di Lonely Planet:
The closest you’ll come to being hijacked is to be dragged off by a friendly local to drink tea and chat.
In terrazzo ho fumato – in questi casi si dice “avidamente” – una sigaretta, nel frattempo fissavo la crema di nebbia che offuscava, più in basso, l’aranciastro delle luci della città. Abbiamo continuato a bere acqua e vino dagli stessi bicchieri, poi Lorenzo ha sfogliato le foto panoramiche, scattate prima della guerra, su Aleppo. Nel cuore della città si alzava un piccolo tavoliere elevato, riempito a complessi di sincretismo bizantino-islamico in grado di parlare all’ancestrale di europei, levantini e arabi. Nelle foto più recenti: muri solitari, bastioni rovinati sul pendio di una collina, l’arenaria ocra coperta dal grigio della polvere di macerie. Il ritratto di ogni non-luogo del Medio Oriente.
Ammessa la necessità di distogliere lo sguardo, ho tentato di assecondare la logica che mi aveva respinto dallo schermo.
I giornali, i video che mostrano i conflitti mi appagano. La loro offerta è la possibilità di sentirmi una persona più consapevole, più matura; in qualche impeto di onniscienza, arrivo anche a cullare l’idea di aver capito il lato più intimo della Guerra. Però l’abbonamento al New York Times non serve a informarmi, ma a placare la tensione morale di un abitante del Primo Mondo, di uno che ha tutto, di uno che può scegliersi il mestiere, il colore del dentifricio e i gemelli per i giorni di festa. Al prezzo di 1,75 Euro alla settimana posso saziare quel preciso senso di colpa, come se sapere che la mia vita somiglia più a quella di uno sceicco che a quelle di un terzo della popolazione mondiale possa bastare per continuare a viverla senza troppi patemi. Io, quando ho visto il cadavere di Alan Kurdi con la faccia sulla sabbia di una spiaggia turca, ho vissuto un attimo di profondo cordoglio. Io so che non è vero che chi scappa dalla guerra non merita rispetto. Io non sono come quegli altri. Io sono un essere umano tutto sommato accettabile, mi ripeto, e riesco anche a convincermene.
Credo sia questo motivo per cui alla televisione non passano le foto di com’era Aleppo prima, o di quanto fosse pacifica la prima ondata di proteste in Siria: perché la cittadella di Aleppo ricorda Atene, se non addirittura Roma. Perché le loro richieste superavano le nostre in razionalità e ragionevolezza. È più facile rimandare le cause dei conflitti all’arretratezza culturale o a qualche gene a forma di Kalashnikov.
Nessuno può assicurarmi che, poco importa la caduta del Muro o la Nato, se Roma e Aleppo sono così simili nulla impedisce che un giorno Roma sarà davvero Aleppo, e che se le loro allegre proteste sono finite in mezzo milione di morti non possa succedere lo stesso alle nostre.
Se mandassero in onda le immagini di Aleppo, di com’era dieci anni fa, Io cambierei canale.