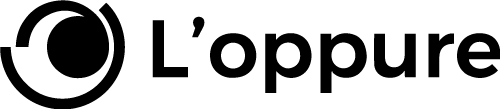Omeros, come Omero, come l’Odissea, il Bardo, l’epica riscritta nel ventesimo secolo. Una storia, un lungo, complesso, poema che racconta le vite di due pescatori che sembrano due guerrieri, che spiega un arcipelago, quello Caraibico, simile alla Grecia, con le infinite sponde straniere, la sconfitta. Infine, l’amore di una donna, una Elena contemporanea che fa la cameriera in un hotel di Saint Lucia, una piccola isola al centro del Mar dei Caraibi. Un grande, quotidiano, narrare epico capace di spiegare il colonialismo, l’antico dominio inglese e la povertà, i visi pallidi degli occidentali e la cultura creola, compresa per adozione più che per nascita.
Un testo che racconta, in una forma arcaica resa attuale, la globalizzazione, il perdersi di una tradizione, un’invasione che non è più quella politica degli stati europei ma, piuttosto, è economica e di sostanza, condotta da schiere ed eserciti di turisti, affaristi e uomini con gli occhiali da sole. Una strana, evocativa, poesia marina dotata di un ritmo e di colori che ricordano il caldo, le corte onde che si infrangono sulla spiaggia, il sole forte, l’umidità. Immagini che rimandano alle luci estive serali, i tramonti rossi, i suoni della calma.
Scritto da Derek Walcott, poeta inglese (nato, però, nell’isola di Saint Lucia nei Caraibi) premio nobel per la letteratura nel 1992, Omeros è una sfida, un prodotto inusuale, che si scontra con la contemporaneità, con i dettami e gli assiomi, non solo nel campo della scrittura, della postmodernità: voler fare narrazione epica negli anni novanta, laddove altri scrittori, come Thomas Pynchon, hanno teorizzato la pastiche di citazioni e rimandi come unica forma letteraria possibile, è sicuramente una presa di posizione interessante, che fa domandare, che vuole significare. Appare come un tentativo, riuscito, di raccontare una tradizione, un mondo, quello dei pescatori e della civiltà creola, e una cultura in via d’estinzione, che da tempo non ha più un’identità, schiacciata e divorata dall’ansia produttiva e dalla logica del capitalismo occidentale, persa tra gli scatti fotografici dei turisti vestiti con le camice di lino.
Walcott sceglie di affidarsi, nel suo narrare, alla forma metrica dell’esametro, tipica del poema epico greco e latino, dividendo i versi in stanze da 3, in cui il secondo verso di ogni stanza rima con il primo e il terzo della successiva, secondo uno schema che ricorda anche la rima dantesca. La struttura del racconto ricorda, per certi versi, una sorta di montaggio parallelo tipico del linguaggio filmico (che, d’altronde, l’ha ereditato dal romano europeo ottocentesco): il narratore non concentra tutta l’azione su un personaggio principale, ma costruisce tre filoni narrativi indipendenti che si intrecciano occasionalmente e senza condizionarsi. Il primo filone narrativo riguarda i personaggi di Achille e Ettore (Hector) e il loro amore per Elena (Helen), in cui compare anche Filottete (Philoctete), un pescatore con una ferita fetida; il secondo tratta del sergente maggiore Plunkett e di sua moglie Maud, di origini irlandesi, che risiedono sull’isola e cercano di riconciliare le loro coscienze con la storia della colonizzazione britannica di Santa Lucia; il terzo e ultimo filone ha come protagonista lo stesso narratore, che commenta l’azione del poema e partecipa lui stesso a viaggi transatlantici e ad altri spostamenti.
La scelta della forma narrativa epica non rappresenta un unicum di Walcott, comunque, nel panorama letterario contemporaneo. Ad esempio, Richard Blanco, poeta americano di origini cubane, ha scritto nel 2013 dei versi celebrativi, in occasione del secondo insediamento di Barack Obama alla casa bianca, che erano ascrivibili a una sorta di epica americana, una narrazione identitaria delle origini, connesse con il fenomeno dell’immigrazione, degli Stati Uniti d’America. Si assiste, dunque, quasi a una rinascita, a una nuova necessità del fare epica, del raccontare culture, creare senso di appartenenza.
Carlo Selan nasce a Udine nel 1996 e attualmente frequenta la facoltà di Lettere presso l’Università di Trieste. Attualmente, scrive e collabora per diversi blog e riviste di cultura come L’oppure, Constraint Magazine, TX2teatriudine, Digressioni, TamTam, ARGO – poesiadelnostrotempo.